PREZZO-COSTI-TARIFFE- INFEDELTA' CONIUGALE INVESTIGAZIONI SOSPETTO INFEDELTA'
SOSPETTO INFEDELTA' del PARTNER? -
AGENZIA IDFOX s.r.l. leader nella tecnologia avanzata !!!
- since 1991 -
Da 30 anni smascheriamo l'infedele.
Perché scegliere IDFOX s.r.l.
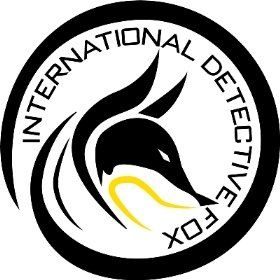
Quanto costa un'indagine di infedeltà coniugale?
Formulare o determinare un prezzo preciso e’ complicato non conscendo le investigazioni per infedelta’ coniugale, in quanto, le indagini per scoprire un tradimento del partner si basano su diversi fattori, come le indagini da svolgere, citta’-località’ e situazioni in cui dovranno essere svolte ecc. comunque il costo minimo per le investigazioni per infedelta’ -la tariffa oraria minimo e’ di euro 55 oltre iva e spese per agente coinvolto nelle indagini; mentre la tariffa giornaliera minima parte da euro 600 oltre iva e spese. E’ importante notare che ogni caso è unico e i prezzi possono variare considerevolmente. Alcuni investigatori privati potrebbero richiedere tariffe
Inferiori snche di euro 30.
DIFFIDATE di chi richiede costi inferiore ! Sono degli abusivi, non hanno le regolari autorizzazione, non dispongono di un team di investigatori privati… sono di truffatori.
In oltre 30 anni di esperienza e capitato piu volte che diversi clienti hanno lamentano di aver corrisposto degli acconti a dei presunti detective che non hanno mai fornito prove del lavoro svolte e non hanno piu risposta ai vari solleciti ne’ telefonici ne’ via mail. DIFFIDATE- DIFFIFATE .DIFFIDATE-
Siamo specializzati nelle investigazioni atte ha smaschererà gli infedeli
L'indagine per infedeltà coniugale viene svolta nel totale rispetto della privacy e sarà corredata da una serie di documenti probatori che l'investigatore privato fornirà attraverso riprese fotografiche e audio-visive, scaturite dal pedinamento effettuato sulla persona indagata. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516/2014, ha affermato che è lecito raccogliere prove per mezzo dell'investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l'adulterio coniugale ed addebitare la separazione al coniuge infedele.
Questo tipo di indagini si rivolge a chi desidera accertare un comportamento infedele del partner, che potrebbe essere coinvolto in una relazione extraconiugale , siamo inoltre specializzati a svolgere indagini OSINT e SOCMINT sui social media, raccogliendo elementi digitali relativi all'infedeltà in atto.
Le investigazioni in ambiti privati e familiari sono tra le più richieste e i costi giornalieri partono da un minimo di 500 euro ad un massimo di 800 euro. In ogni caso, i prezzi non sono comprensivi di iva e eventuali spese extra.
IScopri quali sono le conseguenze legali dell'infedeltà coniugale, i segnali e tutto quello che devi fare se sospetti un tradimento.
L'infedeltà coniugale è la mancanza di fedeltà affettiva, sentimentale o sessuale in un rapporto di coppia esclusivo. Il suo concetto morale varia a seconda dei contesti storici e sociali. Ancora oggi alcuni ordinamenti giuridici la perseguono come reato, in alcuni casi estremi anche con la lapidazione.
La legge sull'adulterio. La risposta è no, tradire il marito o la moglie non è un reato punito dal codice penale. Eppure non è sempre stato così.
INFEDELTA’ CONIUGALE-RISARCIMENTO DANNI
La sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile ha sancito il principio di risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale.
La relazione extraconiugale può determinare un trattamento risarcitorio, il tradimento di un partner può comportare un equo risarcimento in favore del coniuge tradito, secondo i generali criteri della responsabilità civile (articoli 2043 e 2049 Codice Civile), laddove si attesti che tale comportamento abbia comportato danni alla salute e alla dignità della persona tradita.
Ogni prova raccolta dall’agenzia Investigativa IDFOX Milano , professionisti “autorizzatati” dell’agenzia di investigazioni IDFOX è utilizzabile in sede giudiziaria.
Risarcimento per infedeltà coniugale per tradimento coniugale si ottiene solo nel caso sia possibile dimostrare l’infedeltà del partner ed i disagi psicologici e fisici patiti dal partner oppure il tradito risulta leso nella sua dignità, attraverso un comportamento in pubblico che alimenta le dicerie nei suoi confronti.
INFEDELTA' DEL PARTNER?
Hai un sospetto?
Parla con i professionisti, Ti forniamo le prove per uso Legale. Siamo concreti, riservati, professionali con competenze e know-how.
Tempi difficili per l’infedeltà coniugale.
Agenzia Investigativa IDFOX Since 1991
Via Luigi Razza 4 – 20124 – Milano
TEL. 02344223 (r.a.) h24 026696454
www.idfox.it - mail: max@idfox.it
Agenzia investigativa con sede a Milano
- ESPERIENZA ULTRA TRENTENNALE.
- REPORT VALIDO PER USO LEGALE.
- AGENZIA REGOLARMENTE AUTORIZZATA DALLA PREFETTURA DI MILANO.
RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA
Ecco come capire realmente se il tuo partner ti sta tradendo
In questa lista ti proporremo dei consigli generali per capire se c'è la possibilità che il tuo partner ti tradisca, tra i quali c'è anche la possibilità di affidarsi all’agenzia investigativa IDFOX che svolga le indagini al posto tuo, in modo più sicuro ed efficiente.
Ecco alcune cose da tenere presente, che possono svelare una possibile infedeltà:
Investigatore Privato, Cosa succede se uno dei due coniugi non vuole
Non c’è alcun valido motivo per opporsi al divorzio tranne un’eventuale riconciliazione dei coniugi.
Non sono rari i casi in cui un coniuge non voglia concedere il divorzio all’altro. Le ragioni alla base del rifiuto possono essere di natura diversa ad esempio per una ripicca, per evitare che l’ex marito o l’ex moglie convoli a nuove nozze o per ragioni economiche posto che con il divorzio si perdono tutti i diritti successori nei confronti dell’ex partner e l’assegno divorzile spetta solo se si versa in stato di bisogno. Pertanto, cosa succede se uno dei due coniugi non vuole divorziare?
La risposta è semplice: si può iniziare una causa in Tribunale, presentando una domanda di divorzio giudiziale.
Il diritto al divorzio infatti è un diritto irrinunciabile, riconosciuto a ciascun coniuge anche senza il consenso dell’altro.
Esiste però una ragione valida per opporsi al divorzio rappresentata dall’eventuale riconciliazione intervenuta tra i coniugi. Posto che per legge tra la separazione e il divorzio deve intercorrere un determinato periodo di tempo, se durante tale periodo la coppia ad esempio dovesse tornare a vivere stabilmente insieme, la separazione si interrompe. Perciò, se i due intendono divorziare, dovranno procedere a una nuova separazione.
Indice
* Come si può divorziare?
* È possibile rifiutare il divorzio?
* Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?
* Quando è possibile opporsi al divorzio?
Come si può divorziare?
Il divorzio può essere di due tipi:
* consensuale, quando i coniugi trovano un accordo su come proseguire la propria vita dopo lo scioglimento definitivo dell’unione matrimoniale con riguardo agli aspetti patrimoniali (vedi l’assegnazione della casa familiare o l’assegno di mantenimento) e/o agli aspetti riguardanti i figli (affidamento, collocamento, mantenimento, diritto di visita del genitore non collocatario).
Per divorziare consensualmente i coniugi possono:
* presentare un’istanza congiunta in Tribunale;
* ricorrere alla negoziazione assistita dai rispettivi avvocati;
* effettuare una dichiarazione in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile ma solo se non hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti;
* giudiziale, quando manca l’accordo tra i coniugi. In tal caso uno dei può rivolgersi al Tribunale affinché pronunci lo scioglimento del matrimonio, se è stato celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se è stato celebrato in chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
A proposito del divorzio giudiziale è importante sapere che grazie alla riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, oggi è possibile presentare con un unico atto, nella specie un ricorso, davanti allo stesso giudice, la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
È possibile rifiutare il divorzio?
Se un coniuge propone all’altro di divorziare consensualmente, ovvero accordandosi tra loro sugli aspetti patrimoniali e/o familiari del divorzio, questi non è obbligato ad accettare la proposta.
Se da un lato però può rifiutarsi di procedere in tal senso dall’altro non può rifiutare il divorzio. Da ciò consegue che essendo il divorzio giudiziale comunque possibile, spetta al coniuge che intende ottenerlo, rivolgersi al giudice.
Non si può quindi impedire il divorzio se uno dei coniugi lo vuole.
Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?
Come già anticipato si può divorziare senza il consenso del coniuge chiedendo il divorzio giudiziale.
A tal fine la parte interessata deve rivolgersi a un avvocato, preferibilmente esperto in diritto di famiglia, perché avvii la causa in Tribunale. Affinché sia pronunciato il divorzio, il richiedente può sostenere semplicemente che “la convivenza è divenuta intollerabile” senza dovere per forza dimostrare l’intervenuta crisi matrimoniale.
Il coniuge che ha rifiutato la proposta di divorzio consensuale, non può che prendere atto della volontà dell’ex marito o dell’ex moglie, eventualmente difendendosi in giudizio e sostenendo le proprie ragioni ma non può opporsi alla pronuncia dello/a scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Può anche decidere di non costituirsi in giudizio; così facendo però non potrà esporre il proprio punto di vista al giudice.
Peraltro, il procedimento farà ugualmente il suo corso e si arriverà comunque ad una sentenza di divorzio.
Quando è possibile opporsi al divorzio?
Una ragione valida per opporsi al divorzio è rappresentata dall’intervenuta riconciliazione tra i coniugi, che ha interrotto la separazione.
Per legge è possibile chiedere il divorzio solo dopo che sono decorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Se in tale periodo i coniugi dovessero riconciliarsi, la separazione cessa.
La riconciliazione potrà avvenire in forme differenti:
* tacitamente, ovvero con un comportamento che è incompatibile con lo stato di separazione (ad esempio i coniugi tornano a vivere stabilmente insieme);
* oppure con una dichiarazione scritta nella quale il marito e la moglie mettono per iscritto l’intenzione di riprendere la vita matrimoniale.
PUBBLICITÀ
In pratica la riconciliazione è l’unico modo per opporsi al divorzio e porta al ripristino della comunione di vita tra i coniugi.
Se la riconciliazione non dovesse sortire effetti positivi, la coppia dovrà procedere a una nuova separazione prima di richiedere il divorzio.
Lascia mai incustodito il cellulare?
Ilary Blasi e l'«investigatore privato» per seguire Francesco Totti
Secondo le ultime ricostruzioni, la conduttrice avrebbe scoperto che la terzogenita Isabel giocava il pomeriggio con due nuovi amichetti, «i figli di Noemi Bocchi». Così si sarebbe rivolta ad un professionista per vederci chiaro: restano però tanti condizionali
Non si ferma la tempesta di indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima presunta verità arriva dal settimanale Chi, secondo cui la conduttrice si sarebbe rivolta ad un investigatore privato per seguire l’ex capitano della Roma. Stando alla nuova ed esclusiva ricostruzione, «Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie a un dettaglio familiare». Che riguarderebbe la figlia Isabel.
La presentatrice, infatti, pare abbia saputo dall’investigatore privato, terzogenita aveva due nuovi amichetti con cui giocava il pomeriggio, «i figli di Noemi Bocchi». Così, per vederci chiaro, avrebbe contattato un detective privato,: si resta ovviamente nel regno dei condizionali, perché sul tema non ci sono né dichiarazioni dei diretti interessati né prove (pubbliche), ma l’affondo del magazine è deciso e dettagliato.
Sarebbe stato lo stesso Totti, infatti, a portare la figlia Isabel «con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda, per sviare ogni sospetto»: ma, appunto, la verità sarebbe venuta presto a galla, portando ovviamente alla rottura. Si mormora pure che l’ex calciatore fosse «circondato dalle tentazioni» e che ricevesse sui social «alcuni messaggi da ammiratrici che tradivano una certa familiarità».
Tante ipotesi, così com’era una supposizione quella avanzata ieri dal portale di gossip secondo cui Totti e Noemi avevano già cominciato una presunta convivenza. Versione immediatamente smentita dal Corriere della Sera, che ha spiegato che l’ex Pupone «sta trascorrendo la sua prima estate da single di ritorno nella sua mega-villa da 25 stanze, all'Eur, insieme al primogenito Cristian».
Analizza il comportamento del tuo partner quando lascia il suo telefono in una stanza da solo, poiché se vuole tenerti qualcosa nascosto, sicuramente tenderà a farlo di meno.
Messaggi cancellati?
Controlla nelle chat quali messaggi siano stati cancellati o meno, difatti WhatsApp al contrario di Telegram ti dà la possibilità d'individuare quale siano i messaggi cancellati, questo potrebbe facilitarti molto le ricerche.
Infedeltà coniugale: ultime sentenze
Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.
Indice
* 1 Crisi della coppia, infedeltà, separazione
* 2 Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
* 3 L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
* 4 Adulterio e intollerabilità della convivenza
* 5 Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
* 6 Valutazione dell’addebito della separazione
* 7 Infedeltà successiva alla crisi coniugale
* 8 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
* 9 Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
* 10 Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
* 11 Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
* 12 Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
* 13 Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
* 14 Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
* 15 Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
* 16 Stabile relazione extraconiugale
* 17 Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
* 18 Richiesta di separazione con addebito
* 19 Violazione dell’obbligo di fedeltà
* 20 Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
* 21 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
* 22 L’infedeltà coniugale
* 23 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
* 24 Degradazione del rapporto coniugale
* 25 Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
* 26 Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
* 27 Infedeltà coniugale e investigatore privato
* 28 Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
* 29 L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
* 30 L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
* 31 La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
* 32 L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
* 33 Fatto ingiusto per la morale della famiglia
Crisi della coppia, infedeltà, separazione
La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.
Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966
Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).
Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035
Adulterio e intollerabilità della convivenza
Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.
Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307
Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130
Valutazione dell’addebito della separazione
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200
Infedeltà successiva alla crisi coniugale
Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259
Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714
Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658
Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084
Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068
Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.
Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761
Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064
Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665
Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.
La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.
Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.
Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463
Stabile relazione extraconiugale
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229
Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33
Richiesta di separazione con addebito
Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.
Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84
Violazione dell’obbligo di fedeltà
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965
Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598
Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.
Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140
L’infedeltà coniugale
L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.
La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).
Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.
Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317
Degradazione del rapporto coniugale
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.
Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639
Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).
Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929
Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.
Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936
Infedeltà coniugale e investigatore privato
Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.
(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi, aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).
Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069
Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.
Tribunale Prato, 18/02/2010
L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).
Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281
L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.
Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887
La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.
Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254
L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.
Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439
Fatto ingiusto per la morale della famiglia
In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.
Cassazione penale sez. I, 04/12/1992
Chat di Whatsapp e Telegram
Accedi alle sue chat online oppure su applicazioni come WhatsApp e Telegram, difatti esse sono usate dalla maggior parte delle persone per messaggiare online, per questo potresti trovare all'interno di esse indizi su una possibile relazione.
Appuntamenti Calendario
Accedi al suo calendario, solamente se il tuo ragazzo/ragazza ne fa uso, difatti in esso potresti trovare moltissime informazioni che ti permetteranno di analizzare la situazione ed i suoi impegni lavorativi e non lavorativi.
Cronologia del Browser
Controlla la sua cronologia all'interno del browser web, stai attento/attenta a non cancellare niente per non farti scoprire e cerca se ci sono chat sospette e link che potrebbero farti sorgere qualche dubbio.
Rivolgiti agli esperti!
L'ultimo metodo che vogliamo analizzare insieme a te è attraverso l'aiuto di un Investigatore Privato dell’agenzia IDFOX, quindi di una primaria 'Agenzia Investigativa di Milano che attraverso la loro esperienza sapranno sicuramente affrontare questa situazione al meglio delle loro competenze fornendoti dati e prove su quanto sta accadendo.
LA DOMANDA DI UN NOSTRO CLIENTE ANONIMO:
"Egregio Investigatore privato
Le scrivo a proposito della situazione che sto vivendo da un po’ di tempo.
Dopo aver letto alcuni sms, mail e aver ascoltato alcune conversazioni Skype con la password di mia moglie, e dopo aver messo una cimice nella sua borsa, ho scoperto che essa aveva iniziato una relazione con un altro uomo.
Vorrei chiederle se le “prove” che ho trovato, hanno una validità ai fini di poter sostenere una richiesta di separazione con addebito a mia moglie. Ma soprattutto, poiché ho un figlio di 4 anni, avrei il consenso di affidamento dello stesso, salvo poi per concordare una “gestione” condivisa?".

MAX MAIELLARO
Direttore - Fondatore IDFOX s.r.l.
ll diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona tutelato dalla stessa Costituzione, che all'art.2 “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Si tratta di un principio generale, che ha come conseguenza altre norme, e in particolare l'art.15 Cost. relativo all' inviolabilità della corrispondenza. Si tratta di diritti che in generale non sono comprimibili o limitabili neanche in un rapporto coniugale o di convivenza.
In poche parole, il matrimonio o la convivenza non servono ad escludere il rispetto della privacy dei componenti della coppia: il diritto alla riservatezza in quanto diritto personalissimo, permane in capo a ognuno di essi.
Il diritto alla riservatezza, quindi, non può essere violato in alcun modo dalla necessità di provare questioni private: i casi di infedeltà vanno scoperti in altri modi diversamente dallo “spionaggio coniugale”, come ad esempio scegliendo delle agenzie investigative che utilizzino metodi leciti e consentiti dalla legge.
I controlli sui tabulati telefonici, sugli SMS del cellulare, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato penale (art. 616 codice penale in merito alla violazione della corrispondenza ordinaria che si estende anche quella informatica o telematica).
Inoltre l'infedeltà coniugale non comporta nessuna conseguenza sulle leggi di affidamento dei figli: anche in questo caso vige la regola dell'affidamento condiviso.
La violazione dell'obbligo di fedeltà, che determina la separazione della coppia, comporta la sola possibilità di addebito della separazione a carico del coniuge adultero con conseguente diritto al solo assegno alimentare e non a quello di mantenimento (qualora il coniuge versi in uno stato di indigenza) e la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell'altro coniuge.
NEWS ARTICOLI E SENTENZE
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa Milano
Spetta l'assegno di divorzio alla ex che si fa licenziare?
La Cassazione ribadisce la natura assistenziale dell'assegno di divorzio e precisa che la legge sul divorzio n. 898/1970 non esclude la misura in presenza di una licenziamento disciplinare della ex moglie
La colpa del licenziamento causato dalla condotta penalmente rilevante della donna non fa venire meno il diritto alla misura, soprattutto se per età e condizioni fisiche non è più in grado di reperire un lavoro in grado di garantirle di mantenersi da sola. L'assegno divorzile del resto ha anche natura assistenziale. Questo in sintesi il contenuto della Cassazione n. 37577/2022
La Corte nel decidere non trascura il fatto che la donna sia stata licenziata a causa del reato concretizzatosi nell'avere usufruito di 56 giorni di malattia indebitamente. Non ha però potuto neppure trascurare il fatto che la donna, di anni 57 e invalida al 60%, difficilmente è in grado di riconquistarsi una sua autonomia, stante le difficoltà a reperire una nuova occupazione.
Non rientra nella disciplina dettata dagli articoli 5 e 9 della legge di divorzio che una sanzione comporti la perdita del diritto all'assegno, soprattutto se, com nel caso di specie, non è contestata la situazione di difficoltà economica e la impossibilità per il coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per provvedere alle sue necessità.
Addebito della separazione alla moglie che nelle foto è in atteggiamenti intimi con un altro
Sono prova della violazione del dovere di fedeltà, che giustifica quindi l’addebito della separazione le foto che ritraggono il coniuge in atteggiamenti amorosi con un’altra persona quando il matrimonio è in corso
Ammissibile e rilevante la prova del tradimento che il marito ha fornito in sede di separazione e sulla quale ha fondato la richiesta di addebito alla moglie. Non c’è dubbio che le foto prodotte ritraggano la signora in atteggiamenti amorosi con un altro uomo in costanza di matrimonio.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1019/2022 conferma l’addebito a carico della donna, come già sancito dal giudice di primo grado.
Una donna impugna la sentenza con cui il tribunale ha dichiarato la separazione coniugale con addebito a suo carico. Impugnazione che però la Corte di Appello di Milano respinge perché, in base all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: “possono costituire prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale e giustificare, pertanto, l’addebito della separazione, le fotografie che mostrano il marito in un atteggiamento di intimità con una donna che, secondo la comune esperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due della relazione extraconiugale
Separazione con addebito: bisogna versare il mantenimento?
Quali sono le conseguenze dell’addebito in caso di separazione o divorzio: gli alimenti e l’eredità.
In caso di separazione con addebito, bisogna versare il mantenimento? La domanda è frutto di un equivoco che merita di essere chiarito. Ciò a beneficio di tutti coloro che, spesso più per questioni di principio, si imbarcano in lunghe e costose cause di separazione e divorzio, rivolte solo ad affermare la propria “estraneità” alla crisi matrimoniale ma senza alcun vantaggio pratico. Infatti, come si vedrà a breve, la cosiddetta «imputazione dell’addebito» non ha alcuna ricaduta su chi dovrebbe versare l’assegno di mantenimento. Le conseguenze infatti ricadono solo su chi il mantenimento lo richiede. Ma procediamo con ordine.
Cos’è l’addebito?
L’addebito è l’imputazione di responsabilità per la fine dell’unione coniugale. In buona sostanza, subisce l’addebito chi ha violato i doveri del matrimonio. Tali doveri sono la fedeltà, la convivenza, la reciproca assistenza materiale e morale, la contribuzione ai bisogni della famiglia, il rispetto per l’altrui dignità.
In pratica, nel momento in cui il giudice emette la sentenza di separazione o di divorzio, dichiara anche – in presenza di specifica richiesta di una delle due parti – se la fine dell’unione matrimoniale è dipesa dalla colpa di un coniuge o dell’altro.
Con l’addebito quindi il giudice attribuisce la responsabilità della separazione o del divorzio al marito o alla moglie, a tutti e due o a nessuno dei due, a seconda delle prove raccolte nel corso del giudizio.
Cosa comporta l’addebito?
L’addebito non comporta obblighi di risarcimento, né sanzioni di altro tipo. Chi tuttavia subisce l’addebito non può:
- chiedere il mantenimento all’ex;
- rivendicare diritti di successione nei confronti dell’ex.
Rinviando la questione del mantenimento al successivo paragrafo occupiamoci per ora della seconda conseguenza: lo stato di erede legittimario. Come noto, un coniuge è erede dell’altro e non può mai essere diseredato. A questi quindi spetta una quota minima del patrimonio del defunto, la cosiddetta “legittima” (di qui appunto il termine “erede legittimario”).
La qualità di erede non si perde per via della separazione ma solo col divorzio. Dunque, se un coniuge muore prima del divorzio, l’altro è ancora suo erede. Tale diritto però si perde se la separazione è avvenuta con addebito.
Con l’addebito bisogna pagare il mantenimento?
Chi subisce l’addebito non deve, perciò solo, pagare il mantenimento all’ex. L’assegno di mantenimento (quello dovuto a seguito di separazione) e l’assegno divorzile (quello dovuto a seguito di divorzio) scattano solo in presenza di una incolpevole disparità di reddito tra i due coniugi e non anche per l’eventuale violazione dei doveri del matrimonio. Sicché, chi è più “ricco” dell’altro dovrà versare a quest’ultimo il mantenimento anche se non subisce l’addebito. L’addebito non incide quindi sulla posizione di chi deve versare il mantenimento ma solo su quella di chi lo deve ricevere (non potendo più pretenderlo).
Ecco perché spesso la battaglia dell’addebito non ha alcun rilievo pratico, come nel caso della moglie disoccupata che chiede l’addebito al marito titolare di reddito da lavoro dipendente. Quest’ultimo infatti dovrà versarle gli alimenti con o senza addebito.
Quando non è previsto l’assegno di mantenimento?
Oltre al caso del coniuge che subisce l’addebito, il mantenimento non è dovuto quando non vi è disparità sostanziale tra i redditi dei due coniugi. Inoltre, non è dovuto se il richiedente ha ancora una potenzialità lavorativa: è in grado cioè di produrre reddito come succede per chi è giovane, formato, con esperienze. Non è poi dovuto quando il richiedente non dimostra che la sua incapacità economica – ossia di poter badare alle proprie esigenze di sopravvivenza – non dipende da propria colpa. Il mantenimento è invece dovuto a chi è malato, disabile, di età avanzata, vive in contesti geografici di forte disoccupazione, ha tentato – senza successo – di farsi assumere.
Con l’addebito bisogna pagare il risarcimento?
L’addebito, abbiamo visto, implica solo la perdita dei diritti successori e del mantenimento. Non comporta l’obbligo di mantenere l’ex, obbligo che deriva invece da un diverso presupposto: quello della disparità economica.
Ci si potrebbe chiedere se con l’addebito bisogna però risarcire l’ex. Ad esempio, il coniuge traditore deve pagare i danni all’altro? Ciò può succedere solo quando la violazione dei doveri del matrimonio incide sui diritti costituzionali del coniuge come l’integrità fisica, l’onore e la reputazione. Quindi, ad esempio, il risarcimento sarà dovuto da parte del coniuge responsabile di maltrattamenti, violenze o che ha tradito in modo plateale, noto cioè alla collettività (con ciò ledendo la dignità dell’altro).
Assegno di mantenimento: cene e viaggi non provano la convivenza
Il principio affermato dalla Cassazione sulla revoca dell'assegno divorzile al coniuge richiedente può essere applicato anche nella separazione ma la coppia formata con il nuovo compagno deve progettare una nuova famiglia
Assegno di mantenimento e nuova convivenza
La Cassazione con l'ordinanza n. 18862/2022 ribalta decisione della Corte di Appello, che in sede di reclamo ha accolto l'istanza di un marito, che non vuole pagare il mantenimento alla moglie da cui si è separato. Vero che la donna ha un nuovo compagno che le paga viaggi, cene e l'ha aiutata a saldare il perito che ha fatto la stima della casa, questi però sono dati che non provano la volontà della coppia di progettare la formazione di una nuova famiglia insieme.
La vicenda processuale
Pronunciata la separazione il Tribunale pone a carico dell'uomo un assegno mensile di 800 euro per la figlia e 200 euro per la moglie, che però contesta e che il tribunale respinge.
L'uomo agisce quindi in sede di reclamo per la revoca delle disposizioni relative al contributo mensile dovuto a moglie e figlia. Ricorso che questa volta viene accolto con la revoca totale del contributo di 200 euro per la moglie e la riduzione a 400 euro di quanto dovuto mensilmente per la figlia. Revoca disposta in ragione della nuova relazione sentimentale intrapresa con un altro uomo, con il quale ha instaurato una comunione di vita materiale e spirituale, tali da poterli considerare una coppia di fatto anche in assenza di una convivenza continuativa.
Il nuovo compagno della donna si è sobbarcato infatti spese importati, come il costo di 5000 euro per il tecnico incaricato di periziare la casa coniugale ai fini della vendita, quelle per viaggi, gite e cene con la donna, che non avrebbe certo potuto permettersi se fosse stata in difficoltà economiche.
Situazione che ha condotto la Corte a ritenere applicabile anche a questo caso di separazione il principio affermato dalla Cassazione che riguarda però l'assegno divorzile, ossia che l'ex coniuge non ha diritto alla misura se si forma una nuova famiglia di fatto con un'altra persona, senza la necessità di una coabitazione continuativa a tale fine, essendo sufficiente una comunità di affetti e interessi economici.
Non basta un nuovo rapporto serve un progetto di vita comune
La donna non si arrende però alla pronuncia della Corte e ricorre in Cassazione, contestando in particolare, con il quarto motivo che l'orientamento giurisprudenziale applicato dalla Corte di Appello e applicato all'assegno divorzile richiede in realtà, ai fini della revoca, non solo la presenza di un nuovo compagno, ma l'instaurazione con lo stesso di un progetto di vista comune e un rapporto consolidato e protratto, tale da incidere positivamente sulle condizioni economiche della richiedente.
Cene, viaggi e aiuti economici non provano la convivenza di fatto
La Cassazione accoglie sia il secondo motivo con cui è stata contestata la diminuzione dell'importo del mantenimento per la figlia, che il quarto motivo, rigettando gli altri.
In effetti, rilevano gli Ermellini, per la revoca dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, la nuova convivenza non esclude automaticamente la misura.
La nuova relazione deve presentare i caratteri della stabilità e della continuatività, anche in assenza di una coabitazione ma anche "l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto."
Solo così si crea la comunione spirituale e materiale di vita che richiede l'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale, che permette identificare il nuovo nucleo come una famiglia di fatto.
Ipotesi che nel caso di specie non è riscontrabile in quanto la donna e il nuovo compagno hanno due distinte residenze. La Corte non ha approfondito inoltre l'effettiva sostanza del rapporto, in merito alla volontà di dare vita a una comunione di vita stabile tale e a nuovo nucleo familiare. La Corte di è limitata a dedurre i dati suddetti solo da viaggi frequenti, cene e dall'aiuto economico dato per il pagamento della perizia, senza preoccuparsi di indagare se tale aiuto fosse da ricondurre alla volontà di mantenere la donna in senso ampio, né di capire quale fosse l'apporto economico della stessa, di tipo personale o economico a fronte di queste erogazioni di denaro.
Assegno divorzile e convivenze: l'evoluzione della Cassazione
In recenti ordinanze sopravvive un avventuroso collegamento dell'assegno divorzile con la stabilità delle convivenze e il contributo dei nuovi partner
Assegno divorzile e nuovi legami
Sono frequentissimi, e in numero crescente, gli interventi della Cassazione sulle problematiche connesse con l'assegno divorzile. Mettendo da parte le questioni relative all' an e al quantum, pure oggetto di ampio dibattito, riveste crescente interesse il tema della eventuale perdita del diritto a ricevere l'assegno divorzile, che qui si tenterà di analizzare nel suo sviluppo logico attraverso alcune delle numerose pronunce anche prescindendo, qua e là, dalla successione temporale.
Il tutto nasce dal comma 10 dell'articolo 5 della legge 898/1970, che mette fine a tale diritto con il passaggio a nuove nozze. Di conseguenza, anche se certamente vi concorrono altre motivazioni, in un consistente numero di casi il beneficiario, pur in presenza di un nuovo importante legame affettivo, ha preferito la convivenza a un secondo matrimonio. Qualcosa di analogo era stato osservato per le vedove di guerra, che intendevano evitare la perdita della pensione.
Valenza della coabitazione
D'altra parte, la progressiva assimilazione delle convivenze ai matrimoni, fino alla introduzione del concetto di "famiglia di fatto", pur essendo stata pensata per una maggiore tutela dei soggetti più deboli all'interno delle coppie, ha finito per danneggiare proprio loro nella particolare fattispecie della percezione dell'assegno divorzile, come se si fosse voluto mettere fine alla possibilità di camuffamenti e sotterfugi. Una penalizzazione che è sembrata evitabile facendo a meno di coabitare ufficialmente, ovvero se il nuovo partner mantiene la residenza in altro luogo. A sua volta, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta precisando che per poter definire more uxorio una convivenza la condizione della coabitazione non era né necessaria né sufficiente. Una precisazione assolutamente logica. Difatti, possono aversi coppie anche coniugate che per motivi di impegni di lavoro o di comodità logistiche decidono di avere residenze diverse e di non abitare permanentemente sotto lo stesso tetto. Basti pensare a professioni come quelle che richiedono ad uno dei coniugi una grande mobilità. Allo stesso tempo è comunissima, ad esempio, la coabitazione tra studenti universitari, tra i quali, tuttavia, non esiste alcun impegno di vita.
La coabitazione, pertanto, sopravvive come elemento indiziario, ma cede il ruolo di fattore determinante. Il che, d'altra parte, apre all'organo giudicante il problema dell'ancoraggio ad aspetti affidabili ai fini della classificazione del rapporto. Ambiguità risolta da Cassazione 14151/2022 che sul punto così si esprime: "In materia revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale".
Stabilità e famiglia di fatto
Tuttavia, accanto alla problematica della natura del rapporto interno alla coppia va posta quella delle ulteriori condizioni che possono salvare l'assegno divorzile o condurre alla sua caducazione, identificate dalla Suprema Corte nella "stabilità" del rapporto e già affrontata, ad es., da Cassazione 17453/2018: "ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente…".
Tuttavia, compiuto questo importante passo avanti sul piano teorico, non sembra che si sia ancora potuti giungere a conclusioni certe e definitive. Resta, infatti, aperto un serio problema, che in qualsiasi momento può essere posto, rappresentato dalla riconoscibilità stessa della "stabilità" dell'unione. In effetti, non sono mancati i riferimenti, per replicare all'obiezione, alla legge 76 del 2013 che nel definire le unioni di fatto invoca tale concetto al comma 36 dell'art.1 : "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale". Il problema è, purtroppo, che molto realisticamente la medesima legge ai commi 59 e seguenti del medesimo articolo disciplina la conclusione di tale rapporto e del relativo contratto, ammettendo anche il recesso unilaterale. Evidentemente considerandone la precarietà.
Una connotazione che rende del tutto opinabile e inaffidabile l'attribuzione di stabilità a quel rapporto, che è una condizione essenziale per poter affermare che è stata costituita una unione di fatto. Esattamente ciò che vale anche per il soggetto separato e il suo nuovo partner. Sembra dunque di poter concludere che per poter definire un legame successivo al divorzio come unione di fatto è opportuno rinunciare al parametro della stabilità e fare appello ad altre circostanze come l'esistenza di un progetto comune di vita, ad esempio rappresentato dalla presenza di figli. O, quanto meno, ancorare oggettivamente il concetto di stabilità ad una durata minima temporale che venga indicata dalla norma stessa.
La sopravvivenza della componente compensativa
D'altra parte, la Suprema Corte dimostra il suo sostanziale favor per la conservazione dell'assegno enunciando a Sezioni Unite un principio di diritto che distingue tra le componenti dell'assegno e ne salva quella compensativa, sia pure sotto condizione, anche in presenza di famiglie di fatto (sentenza S.U. 32198 del 2021): "Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ha diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio".
In altre parole, è stata respinta la possibilità di una caducazione automatica e totale del diritto all'assegno di divorzio, affermando che ciò, al di là dell'assenza di una base normativa in tal senso, avrebbe anche tradito lo spirito e la funzione di tale assegno, una volta riconosciutane la valenza plurima, e non solo assistenziale.
Nuovi obblighi e nuove risorse
Questa ulteriore precisazione, tuttavia, non ha ancora potuto mettere la parola fine alla problematica, poiché giustamente si è ritenuto che non si potesse prescindere dalla presenza di nuova prole e dalla consistenza economica dei nuovi partners.
La riflessione si articola necessariamente su due piani: quello del percettore di assegno, il cui nuovo bilancio ricomprende le risorse del convivente, e quello dell'obbligato, che tipicamente deve far fronte a oneri aggiuntivi per la nascita di nuovi figli. Il tutto complicato da altri fattori, come l'attribuzione dell'onere di provare che esiste una convivenza, che questa è stabile e che reca vantaggio al beneficiario; ovvero che, eventualmente, aggiunge passività e costi nel caso in cui si tratti di persona priva di risorse a carico dell'obbligato. A cui si aggiunge la difficoltà di indagare sul patrimonio e sui cespiti di soggetto terzo rispetto alla coppia. Pur rammentando, infatti, che l'art. 337 ter c.c. al comma 6 permette al giudice di estendere il controllo a beni e redditi anche intestati a soggetti diversi dalle parti, l'intrinseca delicatezza di una operazione del genere ha fatto sì che gli esempi siano tutt'altro che frequenti.
Entrando nello specifico, secondo un primo orientamento, da tempo superato, di fronte all'obiezione da parte dell'obbligato di dover sostenere l'onere del mantenimento di nuova prole si affermava che, essendo la procreazione una scelta e non una necessità, nulla doveva essere modificato rispetto agli impegni già presi per effetto del precedente legame (Cass. 15065/2000 e 12212/2001). Una tesi respinta immediatamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, facendo notare che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale. Pertanto, si cercò di conciliare le nuove esigenze familiari con le antiche affermando che "allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia" (Cass. n. 21919/2006).
Un enunciato dove si nota subito come non ci si riferisca solo alla prole, ma si prenda in considerazione il nucleo familiare tutto intero, ovvero anche i nuovi compagni. Coerentemente con quanto ancor più esplicitamente sostenuto in Cass. 1179/2006, questa volta però con esclusivo riferimento al beneficiario: "… in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius … delle condizioni economiche dell'avente diritto, … onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius … può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive ".
Una sottolineatura ragionevole, quella del non automatismo del vantaggio economico e della necessità di considerare le risorse del nuovo partner, correttamente evidenziata da Cass. 14921/2007, secondo la quale "La convivenza more uxorio, pur ove acquisti carattere di stabilità, non dà luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano."
Una enunciazione, tuttavia, che in seguito è stata smentita più volte, sia sul piano dell'onere della prova che su quello della presunzione di vantaggiosità. Fino, ad es. a Cass. 15241/2022, (che rimanda alla S.U. 321198/2021), secondo la quale "il coniuge obbligato a corrispondere l'assegno può limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci".
Resta il fatto che la logica osservazione di Cass. 14921/2007 sembra adattarsi in pratica molto meglio alle situazioni in cui viene a trovarsi l'obbligato, piuttosto che il beneficiario. Considerazione che trascina l'interprete verso valutazioni socio-politiche, essendo tipicamente la donna il coniuge debole, che nel nuovo rapporto si lega a chi sta meglio di lei, mentre per la ragione inversa l'ex marito non di rado, instaurando una nuova relazione, si carica di ulteriori pesi economici.
Conclusioni
Questi ultimi aspetti rimarcano la non trascurabile parte di percorso che resta da compiere per illuminare un quadro assai complesso. Manca ancora, in effetti, un approfondimento su ciò che rappresenta la presenza del nuovo partner con le sue peculiarità nel produrre reddito o viceversa nel necessitare di sostegno e pertanto di rappresentare una non indifferente passività. Mentre si riscontrano con sufficiente ampiezza pronunce che tengono conto degli obblighi dei doveri economici dell'obbligato nei confronti della nuova discendenza, non è stata fatta ancora chiarezza, mediante l'enunciazione di principi di diritto, sulla valenza da attribuire nell' an e nel quantum alla presenza nel gruppo familiare di nuova costituzione di un soggetto adulto che rappresenti una fonte di contributi o di bisogni. La casistica si presenta tutt'altro che semplice. Si pensi, ad esempio che l'obbligato potrebbe essersi accompagnato ad altra persona in una varietà di situazioni, sia sotto il profilo del legame che sotto quello delle risorse, in assenza come in presenza di nuova prole, al mantenimento della quale è chiamato anche l'altro genitore. Una varietà di situazioni che non sempre sarà facile disciplinare nel momento in cui non si intende accettare l'idea che il divorzio sia tombale rispetto al matrimonio, rinunciando a proiettare illimitatamente il principio di solidarietà, certamente validissimo di per sé, ma forse non pensato per chi ha scelto la propria indipendenza recidendo i precedenti i legami.
In definitiva, si può concludere che, dal momento in cui la Suprema Corte nell'applicazione dell'assegno divorzile previsto dalla legge 898/1970 si è dovuta addentrare in una moltitudine di sottocasi, sempre più sono apparse le difficoltà legate alla scelta di rendere economicamente indissolubili i legami di coppia.
Quando si rivaluta l’assegno di mantenimento?
Adeguamento dell’importo degli alimenti all’inflazione: la svalutazione monetaria viene calcolata secondo gli indici Istat ma è necessario che sia indicata nella sentenza di separazione o divorzio.
Non è detto che l’assegno di mantenimento all’ex coniuge duri in eterno, potendo la sua sopravvivenza dipendere da una serie di eventi come, ad esempio, il mutamento delle condizioni economiche di uno dei due coniugi o la stessa morte. Ma poiché in genere si tratta di un’obbligazione destinata a durare nel tempo, è normale chiedersi quando si rivaluta l’assegno di mantenimento. Esiste un metodo di aggiornamento automatico dell’importo all’inflazione secondo gli indici Istat (così come previsto, ad esempio, in tema di locazione) e come fare, in caso contrario, a ottenere un incremento dell’importo quando il costo della vita cresce? Cerchiamo di spiegare come e quando si rivaluta l’assegno di mantenimento.
Rivalutazione assegno di mantenimento: quando?
Partiamo subito col dire che il problema della rivalutazione degli alimenti al costo della vita riguarda principalmente l’assegno divorzile, quello cioè conseguente al divorzio. Invece l’assegno di mantenimento, quello cioè conseguente alla separazione, è destinato a durare poco tempo, troppo poco per potersi porre la questione di un’eventuale svalutazione. Ricordiamo infatti che le parti possono chiedere il divorzio già dopo soli sei mesi se hanno intrapreso una procedura di separazione consensuale o, al massimo, entro un anno in caso di separazione giudiziale.
Resta chiaramente ferma la possibilità, per gli ex coniugi, di rimanere separati per sempre, senza cioè procedere col divorzio: si tratta di una scelta libera che l’ordinamento non può loro imporre. Peraltro, in alcune situazioni, la condizione di separazione conviene a quella del divorzio, mantenendo i diritti ereditari, e quindi anche la pensione di reversibilità, l’uno sull’altro. Sul punto consigliamo di leggere l’articolo Conviene divorziare o restare separati?
Come viene rivalutato l’assegno di mantenimento o di divorzio?
La legge prevede solo indirettamente la possibilità di una rivalutazione automatica all’inflazione dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento. L’articolo 5 comma 7 della legge sul divorzio (la legge n. 898/1970) stabilisce solo il potere del giudice di disporre «l’obbligo, per un coniuge, di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Ma la formulazione della norma è tanto ampia da consentire al magistrato di prevedere delle forme di adeguamento automatico al costo della vita.
Dunque, il tribunale nella sentenza di divorzio deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
In questo modo, si tiene conto della svalutazione monetaria, per mantenere all’assegno, nel tempo, un valore il più possibile coerente con il costo della vita, senza imporre un criterio fisso per l’adeguamento.
Il parametro utilizzato correntemente è l’indice Istat relativo al costo della vita. Se la sentenza non prevede alcun criterio di adeguamento si ritiene applicabile tale indice.
Il giudice può prevedere la rivalutazione automatica dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile anche se la parte non glielo chiede espressamente e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, fatti salvi i casi di palese iniquità in cui il tribunale può escludere la rivalutazione con motivata decisione.
Considerato che il reddito si deve valutare in relazione al suo potere d’acquisto nel momento in cui viene percepito, per valutare la sussistenza dei presupposti per la revisione dell’assegno di divorzio è corretto rivalutare il reddito percepito dal coniuge obbligato al momento della sentenza di divorzio per poterlo comparare con quello attuale, tenuto conto altresì che l’assegno è soggetto a rivalutazione.
Cosa succede se il tribunale non prevede la rivalutazione dell’assegno di mantenimento?
Se il giudice dimentica di indicare, nella sentenza di separazione o divorzio, un criterio di adeguamento degli alimenti al costo della vita è da escludere che il coniuge percettore possa ugualmente pretendere le maggiorazioni. A tal fine, dovrà nuovamente rivolgersi al giudice affinché proceda alla correzione della sentenza.
Mantenimento: sono dovuti gli interessi?
Secondo la Cassazione, la condanna al pagamento dell’assegno di divorzio fa sorgere in capo all’avente diritto un credito che produce interessi corrispettivi. Ciò ovviamente succede solo nei casi in cui il coniuge tenuto al versamento degli alimenti è in ritardo rispetto alla scadenza stabilita dal giudice nella sentenza di separazione o divorzio.
Si può pignorare l’assegno di mantenimento?
Differenza tra alimenti e mantenimento: limiti entro cui si può pignorare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge.
Con una storica sentenza di due anni fa, la Cassazione ha detto che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio non ha natura alimentare e, pertanto, può essere compensato con eventuali crediti vantati dallo stesso coniuge obbligato nei confronti dell’ex. La questione ha fatto subito sorgere una domanda: si può pignorare l’assegno di mantenimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione per comprendere cosa dice la legge in merito ed, eventualmente, entro che limiti si può pignorare l’assegno di mantenimento.
Si possono pignorare gli alimenti?
L’articolo 545 del Codice civile stabilisce testualmente che «non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti», e sempre previa l’autorizzazione del giudice. Ma che significa questa frase? Per comprenderla bisogna sapere che gli «alimenti» sono tecnicamente una cosa ben diversa dal «mantenimento» dovuto all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Tutte le volte in cui una persona si trova in condizioni di estremo bisogno economico, tanto che la sua stessa sopravvivenza è a rischio (si pensi a un disabile che non può più lavorare), i suoi familiari più stretti (coniuge, figli, nipoti, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) e, in subordine, eventuali donatari hanno l’obbligo di sostenerlo. Il che significa non già mantenerlo ma dargli lo stretto necessario affinché non abbia a subire un grave pregiudizio fisico. Questo sostentamento, che è rapportato alle possibilità economiche del soggetto obbligato, va appunto sotto il nome di alimenti.
L’assegno di mantenimento è dunque cosa assai diversa: si tratta infatti della somma che, in caso di cessazione del matrimonio, il coniuge con il reddito più alto deve versare all’ex se questi non è autosufficiente. Il mantenimento è un importo di norma più elevato degli alimenti perché non mira a garantire solo la sopravvivenza ma anche un tenore di vita decoroso.
Ebbene, l’articolo 545 del Codice civile stabilisce che solo gli alimenti, e non già il mantenimento, sono impignorabili. Eccezionalmente, si possono pignorare gli alimenti solo quando il creditore agisce, a sua volta, per un credito derivante da altri alimenti.
Si pensi, ad esempio, a una donna che, non potendo lavorare, riceve dal figlio mensilmente gli alimenti. La stessa donna però è debitrice nei confronti del fratello che qualche anno fa le aveva regalato una casa e che ora, anch’egli in condizioni di incapacità economica assoluta, le chiede gli alimenti per sopravvivere. Dunque, il fratello può pignorare alla donna gli alimenti che quest’ultima riceve dal figlio: si tratta infatti di due crediti aventi natura alimentare. Non potrebbe invece pignorarli la finanziaria per il mancato pagamento delle rate, trattandosi di un credito di natura diversa. La misura del pignoramento viene però decisa dal giudice.
Si possono compensare gli alimenti?
Così come non si possono pignorare, gli alimenti non si possono neanche compensare con altri crediti vantati dal debitore nei confronti del soggetto sostenuto. Lo dice espressamente l’articolo 447 del Codice civile. In pratica, chi versa gli alimenti ma vanta un credito nei confronti del soggetto beneficiario degli alimenti stessi non può decurtare dalla somma da lui dovuta quella invece a lui spettante. Potrebbe farlo solo se si tratta di due crediti di natura alimentare.
Si può pignorare il mantenimento del coniuge?
Nessuna norma del Codice civile stabilisce se l’assegno di mantenimento è impignorabile come invece viene detto a chiare lettere per gli alimenti. Qualche giudice ha ritenuto di poter applicare, in via analoga, la stessa disciplina degli alimenti anche al mantenimento, sulla base della finalità cui quest’ultimo era diretto: dare un sostegno economico al coniuge meno abbiente e molto spesso disoccupato.
Senonché, nel 2020, la Cassazione ha detto il contrario, stabilendo che il mantenimento dovuto all’ex coniuge non ha natura alimentare. Il che significa quindi che non è solo soggetto a compensazione ma anche a pignoramento.
Ecco le esatte parole usate dalla Corte: «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare».
Questo lascia intendere che le norme relative agli alimenti non si applicano al mantenimento, non almeno a quello dovuto all’ex coniuge. Valgono invece per il mantenimento dovuto ai figli: per questi ultimi infatti la somma corrisposta dal genitore non collocatario ha la funzione di garantire la sopravvivenza e il sostentamento: essa ha quindi natura alimentare.
Risultato: l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge può essere pignorato; non può esserlo invece quello dovuto ai figli.
Da chi può essere pignorato l’assegno di mantenimento?
Non avendo natura alimentare, l’assegno di mantenimento può essere pignorato da qualsiasi creditore, non solo quello che vanta crediti alimentari. Così potrebbe pignorarlo, ad esempio, una finanziaria, il condominio, il locatore, ecc. Chiunque insomma può notificare un atto di pignoramento al coniuge che versa il mantenimento ordinandogli di bloccare i pagamenti in attesa che sia il giudice a definire l’ammontare delle quote mensili da trattenere e versare al creditore.
Qual è il limite di pignoramento dell’assegno di mantenimento?
Anche se in teoria, in assenza di limiti imposti dalla legge, l’assegno di mantenimento potrebbe essere pignorato per intero, nei fatti poi è sempre il giudice dell’esecuzione a stabilire un ammontare massimo oltre il quale non andare: ciò al fine di garantire una vita dignitosa al suo beneficiario. Se infatti è vero che il mantenimento serve per garantire l’autosufficienza a chi non è in grado di procurarsela, e che il nostro ordinamento è sempre improntato a tutelare la dignità umana, anche in caso di debiti, il tribunale può fissare un limite al pignoramento del mantenuto in modo che la residua parte garantisca al beneficiario le esigenze primarie della persona (la spesa per il cibo, il vestiario, le medicine, i trasporti).
Dunque, se anche non esiste – come per lo stipendio, che è pignorabile entro massimo un quinto – un tetto oltre il quale il mantenimento non può essere pignorato, questa misura viene stabilita caso per caso dal giudice.
Si può pignorare il mantenimento dovuto ai figli?
In conclusione, ribadiamo quanto già detto nell’articolo: se si può pignorare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge meno abbiente, è invece impignorabile il mantenimento per i figli avendo questo natura alimentare.
Illudere l’amante di essere single: è reato?
Quando fingere di avere uno stato diverso da quello proprio (celibe o nubile) è reato di sostituzione di persona.
Non è solo un tipico cliché delle commedie all’italiana quello dell’uomo sposato che finge di essere single pur di ottenere le grazie di una giovane bella e avvenente. L’episodio è talmente frequente da aver interessato finanche le aule di tribunale.
Tuttavia, dinanzi a una donna ferita nei sentimenti per aver creduto a un fedifrago bugiardo, c’è da chiedersi quali implicazioni legali possa avere un comportamento del genere. Carpire la fiducia di un’altra persona, prenderla in giro per sfruttarne “i favori” può comportare una denuncia penale? Per quanto ad alcuni possa apparire solo immorale il fatto di fingere pur di corteggiare una donna, tale condotta è vietata dalla legge. Detto in altre parole, illudere l’amante di essere single è reato.
Di che tipo di reato parliamo? Quello di sostituzione persona previsto dall’articolo 494 del Codice penale.
Contrariamente a quanto potrebbe far intendere la terminologia usata dal legislatore, il reato di sostituzione di persona non scatta solo quando si assume un nome non proprio o l’immagine di un’altra persona senza l’altrui consenso, ma anche quando si assumono titoli o qualità che non si hanno. Ma cosa si rischia concretamente? Vediamolo partendo dal dato letterale della norma.
Cosa si rischia a fingersi single?
Una persona che dice di essere single quando invece non lo è, indipendentemente dal fatto che abbia usato o meno raggiri per farlo credere, rischia la reclusione fino a un anno. Si tratta di un reato che, per la sua gravità, è procedibile anche d’ufficio ossia anche senza la querela della vittima e su semplice iniziativa delle autorità: l’articolo 494 infatti mira a tutelare interessi pubblici, ossia che le persone non si spaccino per altre o non si attribuiscano degli stati o delle qualità a cui la legge ricollega degli effetti giuridici.
Il fatto di dire una bugia sul proprio conto è reato – dice la norma – quando rivolto a procurare a sé o ad altri un vantaggio o ad arrecare un danno ad altri. Il danno può consistere nel carpire il consenso a una relazione, anche se a distanza: non rileva l’assenza di contatto fisico o la mancata consumazione del rapporto stesso per far scattare la responsabilità penale. Basta il semplice pericolo che ciò possa verificarsi. Ragion per cui, se la vittima era in grado di conoscere la verità – ad esempio consultando le foto del profilo social del mentitore – il reato potrebbe non sussistere.
Come evitare la condanna per aver mentito sul fatto di essere sposati
Esiste una norma, l’articolo 131-bis del Codice penale, che consente l’assoluzione per tutti quei reati ritenuti “tenui” ossia che non hanno prodotto particolari danni nella vittima. In tali ipotesi, se anche non si subisce la sanzione penale, si è comunque costretti a risarcire i danni alla vittima e si mantiene la “macchia” sulla fedina penale. Tuttavia, per legge, tale beneficio non spetta per tutti i reati “continuati”, quando cioè la condotta viene ripetuta nel tempo. Dunque, per l’assoluzione, è necessario che la menzogna sia stata scoperta subito o comunque non si sia protratta a lungo.
Fingersi single per chiedere denaro
La Cassazione si è occupata anche del caso di una persona che si era finta single per allacciare una relazione con la vittima e trarne denaro. In questo caso, il fine del profitto è più che evidente.
Secondo i giudici supremi, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall’instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito (nella specie, l’imputata si era finta single, pur avendo un compagno e dei figli, e così era riuscita ad avvicinare un uomo, facendogli credere fosse nato un legame e ottenendone in cambio regali e denaro).
Quali diritti e doveri hanno i conviventi verso i figli?
Rapporti coi figli nel caso di coppia di fatto: riconoscimento, affidamento, mantenimento, collocazione e assegnazione della casa familiare.
I rapporti esistenti tra genitori non alterano i loro diritti e doveri verso i figli. Sicché, anche alle coppie di fatto si applicano le stesse norme previste per le coppie sposate o separate. Dunque, per stabilire quali diritti e doveri hanno i conviventi verso i figli bisogna far riferimento a una qualsiasi coppia di genitori.
A scanso di equivoci, qui di seguito, forniremo alcuni chiarimenti pratici.
Dovere di riconoscimento
Forse, l’unica particolarità che distingue i conviventi dalle coppie unite in matrimonio sta nell’obbligo di riconoscimento che spetta al padre naturale dopo la nascita del figlio. Il riconoscimento, che avviene presso l’anagrafe del Comune di nascita, serve ad ufficializzare il rapporto di genitorialità che, senza tale dichiarazione, non potrebbe sussistere come invece per le coppie sposate. Difatti, il padre della coppia sposata è tenuto solo a dichiarare la venuta al mondo del bambino il quale, a seguito di ciò, si considera automaticamente suo figlio proprio in ragione del rapporto di coniugio che lo lega alla madre.
Il genitore naturale è obbligato a riconoscere il figlio. Se non vi provvede, può imporglielo la compagna o il figlio stesso attraverso un’azione giudiziaria e il test del Dna.
Il padre naturale che non ha riconosciuto il figlio è tenuto a risarcirgli il danno patrimoniale e morale.
Obblighi dei genitori conviventi verso i figli
Come le coppie sposate, anche i genitori naturali assumono nei confronti dei figli tutti i doveri di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Ai doveri dei genitori naturali corrispondono anche i relativi diritti, come ad esempio quello di visita in caso di separazione e il diritto a ricevere gli alimenti dal figlio nel caso in cui il genitore dovesse versare in una situazione di grave difficoltà economica.
I figli delle coppie di fatto sono eredi legittimari: hanno quindi sempre diritto a una quota del patrimonio dei genitori e non possono essere diseredati.
Obbligo di mantenimento durante la convivenza
Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e ciascuno ha il dovere di fare tutto il possibile perché il figlio abbia quanto gli occorre anche nel caso in cui l’altro genitore si renda inadempiente. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Diritti e obblighi verso i figli della coppia di conviventi in caso di separazione
Il rapporto che si instaura tra genitore e figlio nell’ambito della famiglia di fatto ha i medesimi caratteri e contenuti morali e materiali del legame tra genitore e figlio nella famiglia fondata sul matrimonio.
Ne consegue che, in caso di rottura della convivenza tra i genitori, i rapporti tra genitori e figli, dovranno regolarsi in termini identici, sia per l’affidamento che per il mantenimento.
Se non c’è accordo tra i genitori, bisogna ricorrere al giudice il quale prenderà posizione su quattro aspetti:
- l’affidamento del figlio;
- la collocazione del figlio;
- l’assegnazione della casa familiare;
- l’assegno di mantenimento per il figlio.
Quanto all’affidamento, questo è di norma congiunto (spetta cioè ad entrambi i genitori) salvo particolari e gravi incapacità di uno dei due genitori (nel qual caso si provvede all’affidamento esclusivo) o di entrambi (nel qual caso si procede all’assegnazione a una casa famiglia e all’adozione). L’affidamento consiste nel potere di partecipare alle scelte più importanti per l’educazione, la crescita, l’istruzione e la salute dei propri figli. Ragion per cui tutte le principali scelte, in caso di affidamento condiviso, dovranno essere concordate tra padre e madre.
L’affidamento vale solo per i figli minorenni, essendo i maggiorenni capaci d’intendere e volere e quindi responsabili in proprio.
Quanto alla collocazione, ossia alla residenza del minore, questa viene scelta secondo il suo esclusivo interesse presso quella di uno solo dei genitori, con diritto dell’altro di farvi visita a giorni alterni tutte le settimane, secondo il calendario concordato dai genitori o, in assenza di intesa, fissato dal giudice. È dovere del genitore non collocatario andare a trovare il figlio con continuità.
L’assegnazione della casa familiare segue la collocazione del figlio: significa che il giudice attribuisce il diritto di abitazione nell’appartamento ove prima viveva la famiglia al genitore presso cui il figlio va a vivere.
Infine, c’è il mantenimento costituito da un obbligo di contribuzione forfettario alle spese ordinarie e alla partecipazione, di volta in volta, alle spese straordinarie (quelle urgenti e necessarie non devono essere pre-concordate tra i coniugi).
Ciascun genitore, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Ovviamente, l’accordo raggiunto e liberamente sottoscritto dai genitori può prevedere una ripartizione nel concorso degli oneri anche non proporzionale tra gli stessi ma comunque non deve essere contrario all’interesse dei figli. Il giudice, difatti, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori se non contrari all’interesse dei figli.
Un accordo intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi non richiede che sia omologato o controllato dal giudice in via preventiva. Tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo di legge, il suo contenuto deve sempre rispondere all’interesse morale e materiale della prole.
Come funziona il mantenimento del figlio?
Se i genitori non trovano un accordo sull’assegno di mantenimento da versare in favore del figlio minorenne, portatore di handicap o maggiorenne non ancora autosufficiente, il giudice, ove necessario, al fine di realizzare il principio di proporzionalità può determinare un assegno periodico a carico di un genitore e a favore dei figli prendendo in considerazione:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
L’assegno di mantenimento deve essere automaticamente adeguato agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
L’obbligo dei genitori di mantenere la prole che incombe su entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze, non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura, immutato, sino a quando il medesimo non abbia le condizioni (anche solo potenziali) per raggiungere un’indipendenza economica. Questo significa che il figlio ha diritto al mantenimento solo fino a quando porta avanti un progetto formativo o l’istruzione o dimostri che la propria condizione di disoccupazione non dipende da sua inerzia. Al maturare di 30-35 anni, la giurisprudenza revoca l’assegno di mantenimento, presumendo che l’assenza di lavoro dipenda da un comportamento colpevole del giovane.
I figli portatori di handicap grave hanno sempre diritto al mantenimento.
Con chi va a vivere il figlio?
La scelta della residenza abituale del minore deve essere assunta di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice che si basa sul prevalente interesse del figlio e sentendo il suo parere (se ha almeno 12 anni).
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Assegnazione della casa familiare
La disciplina sull’assegnazione della casa familiare dettata dalla legge per le coppie sposate è applicabile ai figli dei genitori non coniugati. Pertanto, in caso di scioglimento del rapporto tra conviventi, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente la casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio
Quali diritti non hanno le coppie di fatto?
Diritti dei conviventi: il compagno o la compagna non hanno diritto al mantenimento in caso di cessazione della convivenza e non sono eredi legittimari.
Quali diritti non hanno le coppie di fatto? Nonostante il progressivo allargamento, operato dalla giurisprudenza, delle tutele previste per le coppie unite in matrimonio anche alle coppie di fatto, restano ancora delle profonde differenze tra chi si sposa e chi invece convive. Prima tra tutte il fatto che, in caso di separazione, al partner non è dovuto alcun mantenimento (salvo gli alimenti in caso di grave difficoltà economica tale da comprometterne la sopravvivenza), né l’obbligo di fedeltà. Ed ancora il convivente non è considerato erede legittimario: a questi quindi non va, di diritto, alcuna quota di patrimonio del defunto.
Cerchiamo, più nel dettaglio, di elencare quali diritti non hanno le coppie di fatto partendo proprio dalle tutele che la legge riconosce loro in modo poi da ricavare l’elenco per esclusione. Ma procediamo con ordine.
Cos’è la coppia di fatto?
La coppia di fatto è quella che convive stabilmente e che pertanto forma ciò che si definisce, in gergo tecnico, una convivenza more uxorio, ossia basata sugli stessi obblighi morali del matrimonio (stabilità, assistenza reciproca, contribuzione ai bisogni della famiglia).
La disciplina della famiglia di fatto è contenuta nella legge 20 maggio 2016 n.76, che definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La coppia di conviventi non deve essere necessariamente di sesso diverso, ben potendo essere rappresentata da omosessuali. Tuttavia, le coppie gay hanno anche un’altra e più incisiva forma di tutela: quella costituita dalla realizzazione di un’unione civile che garantisce loro gran parte dei diritti di una coppia sposata.
La coppia di conviventi può raggiungere tre diversi stadi di maturazione. C’è la coppia di conviventi pura e semplice, dove i due si limitano a vivere sotto lo stesso tetto. C’è poi quella che formalizza la propria situazione al Comune, registrandosi all’anagrafe come un unico nucleo familiare (i due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa). Infine, c’è la coppia di fatto che ha stipulato un contratto di convivenza, regolando così liberamente alcuni aspetti della loro unione e dell’eventuale separazione.
I diritti delle coppie di fatto
I conviventi di fatto, che hanno formalizzato la loro unione all’anagrafe del Comune, costituendo così un unico nucleo familiare, hanno una serie di diritti che vengono riconosciuti tipicamente alle coppie sposate. Ad esempio, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Diritto agli alimenti
Se la convivenza cessa, nessuno dei due partner può chiedere all’altro il mantenimento come invece avviene nelle coppie sposate. Tuttavia, è diritto del convivente chiedere all’ex gli alimenti, una somma cioè appena sufficiente a sopravvivere nel caso questi, per una grave impossibilità (ad esempio, malattia) non sia in grado di procurarsi il necessario. In particolare, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti non durano in eterno ma sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in proporzione alle capacità economiche dell’ex. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto solo se non ci sono figli, nipoti, genitori.
Il diritto agli alimenti in favore del convivente comporta che una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze cessate a partire dal 5 giugno 2016, data a partire dalla quale è stata prevista tale possibilità.
Diritto di abitare la casa comune
Come noto, se muore uno dei due coniugi, l’altro ha diritto di abitare la casa comune fino alla propria morte. Questo diritto è limitato nel caso di conviventi. In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Se la coppia viveva invece in affitto, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Graduatorie nell’assegnazione di case popolari
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 sexies e 609 octies del Codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso, le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.
Diritti del convivente nell’impresa familiare
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Designazione del convivente quale rappresentante
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Astensione dall’obbligo di testimoniare
Il convivente more uxorio dell’imputato rientra tra i soggetti che hanno la facoltà di astenersi dal testimoniare.
I prossimi congiunti dell’imputato possono astenersi dall’obbligo di testimoniare salvo quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. Il giudice deve, a pena di nullità, avvisare tali persone della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
Tali disposizioni si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione e limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale:
- a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
- al coniuge separato dell’imputato;
- alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato.
Quali diritti non hanno i conviventi?
Tutti gli altri diritti che la legge riconosce alle coppie sposate non spettano invece alle coppie di fatto tra conviventi. In particolare, al convivente non spetta il diritto al mantenimento in caso di separazione, ma lo stesso può essere invece previsto nel contratto di convivenza stipulato tra i due.
Al convivente non spetta il diritto alla legittima, ossia a una quota del patrimonio del compagno o della compagna qualora questi dovesse decedere. L’unico modo per garantirgli la partecipazione all’eredità è fare testamento e citarlo espressamente, fermo restando che in presenza di legittimari (figli o, in mancanza, genitori) a questi sarà comunque dovuta una quota prefissata dalla legge. In assenza di testamento, invece, ai conviventi non spetta nulla.
Al convivente non si deve garantire la fedeltà né il rispetto dell’obbligo di convivenza come invece avviene per le coppie sposate. Sicché, non esiste neanche il cosiddetto addebito in caso di separazione. E del resto se la coppia di fatto si separa, non ha bisogno del giudice: la separazione viene attuata di fatto, così com’era iniziata, senza che si possa chiedere un provvedimento del giudice (al quale al massimo ci si può rivolgere per dividere i beni cointestati ossia sui quali si era formata la comunione, anche a seguito di patto di convivenza).
Sempre in tema di regime degli acquisti, ai conviventi non spetta di diritto la comproprietà sui beni acquistati dall’altro, come la comunione tra i coniugi, ma il contratto di convivenza può prevedere diversamente.
Il convivente – al pari del coniuge – non ha diritto a vedersi rimborsati i soldi spesi nell’interesse familiare se la coppia si separa.
Coppie di fatto e adozione
L’adozione nazionale ed internazionale di minori di età è preclusa alle famiglie di fatto.
La legge consente l’adozione solo ad una coppia di coniugi uniti in matrimonio benché consenta la possibilità di tener conto di una convivenza stabile e continuativa tra i coniugi antecedente al matrimonio.
È consentita, invece, ai coniugi, ai singoli nonché a chi non sia coniugato l’adozione in casi particolari nei seguenti casi:
- persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- i minori si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/92 e siano orfani di entrambi i genitori;
- sia constatata l’impossibilità dell’affidamento preadottivo.
Convivenza e procreazione assistita
Possono ricorrere alle tecniche per superare problemi di sterilità le coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Quindi, i conviventi ove siano afflitti da problemi di sterilità possono accedere alla procreazione medicalmente assistita.
Per l’accertamento della convivenza il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti.
L’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è vietato ai minorenni, ai singoli ed alle coppie omosessuali, nonché è impedita la fecondazione post mortem ovvero utilizzando il seme del convivente o del coniuge nel frattempo morto e l’accesso alla genitorialità tardiva.
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
Il contratto di convivenza reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza. La modifica deve essere effettuata in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Niente mantenimento per la figlia maggiorenne
La mancanza di un progetto formativo o lavorativo da parte della figlia maggiorenne, rende immotivato il rifiuto delle due offerte lavorative procuratele dal padre, è colpa sua se la stessa a ventidue anni non è ancora autonoma
Non spetta l'assegno alla figlia maggiorenne senza progetti e volontà
La Cassazione rigetta il ricorso dei figli maggiorenni che si oppongono alla revoca dell'assegno di mantenimento del padre. La figlia femmina in particolare non ha dimostrato negli ultimi anni di avere una progettualità lavorativa o formativa. Sono quindi immotivati i rifiuti alle due offerte lavorative procuratele dal padre. Questi i concetti ribaditi nell'ordinanza n. 16771/2022 della Cassazione, che tira l'ennesima tirata di orecchie ai figli che non studiano e non lavorano.
La vicenda processuale
In un procedimento di divorzio i due figli della coppia chiedono che il giudice disponga l'aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il loro mantenimento da 300 euro a 800 euro.
Il Tribunale però, accogliendo la domanda del padre, revoca completamente il suo obbligo di contribuzione. In sede di reclamo la misura in favore dei figli viene ripristinata nella misura stabilita in sede di divorzio. La Corte prende questa decisione perché rileva che la figlia di 22 anni ha abbandonato l'università dopo un anno senza dare un esame, ha rifiutato due offerte di lavoro procuratele dal padre e ha dimostrato, in diverse occasioni, di essere indecisa sul futuro e poco costante.
Per quanto riguarda il figlio invece, da poco maggiorenne, il quadro lascia aperta la strada a una progettualità.
Assegno più alto se le condizioni economiche del padre sono migliorate
I figli nel ricorrere in Cassazione sollevano le lamentele che si vanno a illustrare.
- La figlia rileva il travisamento dei fatti che emerge dal provvedimento impugnato, ribadendo prima di tutto la mala applicazione dei criteri che la Cassazione stessa detta in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nega la propria assenza di volontà nell'intraprendere un percorso formativo, per cui il giudice ha mal interpretato le ragioni del rifiuto delle offerte lavorative procuratele dal padre.
- Con il secondo i ricorrenti lamentano motivazione apparente del provvedimento.
- Con il terzo contestano il mancato accoglimento della domanda di aumento del contributo in loro favore, stante il venir meno di ogni rapporto con il padre e il miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo per una sopravvenuta eredità.
Il mantenimento per i figli non è una misura assistenziale perpetua
La Cassazione rigetta il ricorso principale, così motivando la sua decisione.
Il primo motivo è inammissibile perché la critica sollevata è astratta e assai generica. Non si precisa nel motivo per quali ragioni la Corte avrebbe violato i principi giurisprudenziali in materia di mantenimento dei figli maggiorenni e non è neppure indicato il fatto che, se non omesso, avrebbe condotto all'accoglimento del reclamo.
Il secondo invece è manifestamente infondato perché la Corte ha spiegato nel dettaglio le ragioni per le quali non dovevano essere accolti i rilievi dei figli. E' infatti emerso dalle prove raccolte che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlia era imputabile direttamente alle scelte della stessa. La giovane ha rifiutato senza motivo diverse offerte lavorative. Non sono emerse inoltre neppure inclinazioni o aspirazioni lavorative tali da ritenere che la stessa stesse seguendo una strada formativa alternativa. Come precisato dalla Corte, il mantenimento per i figli non ha una funzione assistenziale illimitata nel tempo e nel contenuto nei riguardi dei figli maggiorenni e disoccupati. L'obbligo di corresponsione viene meno poi se il mancato raggiungimento dell'autonomia economica è frutto della mancanza di impegno verso un progetto formativo preciso.
Respinto infine anche il terzo motivo, anche perché, la difficoltà dei rapporti intercorrenti tra padre e figli non ha determinato una perdita di interesse dell'uomo. La Corte ha inoltre accertato la contrazione in realtà dei redditi del padre a causa di sopravvenute problematiche di salute.
La Cassazione sulla separazione consensuale
Ecco alcune delle più interessanti sentenze della Cassazione in materia di separazione consensuale:
Cassazione n. 11486/2022
L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile, esso si ritiene ugualmente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli.
Cassazione n. 41232/2021
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa.
Cassazione n. 17908/2019
Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio, e dall'altro, a quello di un atto di vendita; tali attribuzioni svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo immediatamente riconoscibili come tali.
Cassazione n. 6145/2018
La situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, e, pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. Tale pronuncia non definitiva costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perchè è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l'effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio; pertanto, deve reputarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, (nel testo sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8), sollevata in riferimento agli artt. 2, 29 e 111 Cost.
Cassazione n. 16909/2015
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare il cui contenuto essenziale è rappresentato dal consenso reciproco a vivere separati, dall'affidamento dei figli e, ove ne ricorrano i presupposti, dall'assegno di mantenimento. Esso ha poi un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione e che è rappresentato da accordi patrimoniali autonomi conclusi dai coniugi in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Separazione e divorzio in Comune: come si fa
La procedura dinanzi all’ufficiale di Stato civile del Comune per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare, può dirsi addio anche in Comune, presentandosi all’ufficio di stato civile: una novità entrata in vigore poco meno di due anni fa che, tuttavia, è consentita solo a determinate condizioni. In questa breve scheda, vi spiegheremo come separarsi o divorziare in Comune, tutti gli adempimenti burocratici da compiere, i documenti da presentare e i passi da seguire per procedere senza bisogno di avvocati e giudice.
Quando ci si può separare o divorziare in Comune?
La separazione o il divorzio in Comune, presso l’ufficio di stato civile, è consentito solo a determinate condizioni:
- la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. Non vengono considerati i figli nati da eventuali precedenti relazioni: per cui la loro presenza non è ostativa alla separazione in Comune. È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;
- la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto riguarda le questioni più marcatamente personali che patrimoniali. In buona sostanza, la separazione o il divorzio in Comune sostituiscono la cosiddetta separazione / divorzio consensuale che prima si faceva, in un’unica udienza, davanti al Presidente del Tribunale;
- l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, ecc. Dovranno farlo, allora, con un’autonoma scrittura privata tra questi firmata in separata sede oppure ricorrendo alla negoziazione assistita degli avvocati, che è un ulteriore mezzo per separarsi o divorziare (di cui parleremo più in là in questa scheda).
L’accordo può contenere anche patti aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile.
Per coloro che vogliano separarsi consensualmente ma che non si trovano nelle condizioni appena elencate (per es. per via della presenza di figli minori o perché intendano effettuare trasferimento patrimoniali), la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati attraverso il procedimento chiamato “negoziazione assistita”.
Dove ci si deve presentare per separarsi o divorziare?
I coniugi possono recarsi sia presso il Comune ove hanno contratto matrimonio che presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. In particolare bisognerà presentarsi all’Ufficio di stato civile.
Quali documenti occorrono per separarsi o divorziare?
Quanto alla documentazione necessaria per attivare il procedimento innanzi all’ufficio di stato civile, è necessario:
- per la separazione: documento di identità dei coniugi e l’autocertificazione qui allegata (si rilascia la copia in uso a Milano) contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli.
- per il divorzio: documento di identità dei coniugi; l’autocertificazione qui allegata (si rilascia la copia in uso a Milano) contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli. Andrà poi presentata la copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale (se i coniugi si erano separati in via giudiziale in tribunale) o del decreto di omologa di separazione (se i coniugi si erano separati consensualmente in tribunale) o l’originale dell’accordo di separazione (se i coniugi si erano separati con la negoziazione assistita).
Quali costi bisogna sostenere?
Per separarsi o divorziare in Comune non è dovuto solo un diritto fisso di € 16,00 in contanti. Non essendo necessari avvocati, non ci saranno altri costi da sostenere.
Quale procedimento seguire per separarsi o divorziare?
In alcuni Comuni è richiesto un primo e informale incontro solo al fine di verificare la documentazione e la competenza dell’ufficio a ricevere l’atto. Viene quindi avanzata la richiesta di avvio del procedimento (in alcuni Comuni è richiesta la compilazione di un modulo prestampato). In altri Comuni, invece, si deve telefonare per concordare un appuntamento per procedere all’iter di separazione o divorzio.
La procedura vera e propria viene cadenzata in due incontri:
- al primo incontro il Sindaco o l’ufficiale di stato civile redige l’accordo di separazione che i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo aver compilato l’accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;
- al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare. La ragione di questo lasso di tempo è per consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta in atto.
Se al secondo appuntamento si presentano entrambi i coniugi l’accordo di separazione è valido ed ha la stessa efficacia della sentenza di separazione omologata dal tribunale. Il Comune, a questo punto, invia l’atto agli uffici competenti per le annotazioni sull’atto di matrimonio. I coniugi possono sempre chiedere una copia autentica dell’accordo depositato in Comune.
Se, invece, al secondo appuntamento non si presenta uno o entrambi i coniugi, l’accordo di separazione non è valido e decade. I coniugi potranno tuttavia presentarsi in qualsiasi successivo momento per avviare, di nuovo, l’intera procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito.
È necessaria la presenza dell’avvocato?
Nella separazione o divorzio davanti al Comune non c’è bisogno di avvocati; tuttavia nulla esclude che una delle due parti o entrambi si facciano accompagnare da altri soggetti, ivi compreso il difensore.
Dopo quanto tempo il divorzio dalla separazione?
Per chi si è separato e vuole divorziare in Comune, il procedimento può essere attivato solo a condizione che:
- siano decorsi sei mesi, se la precedente separazione era stata consensuale (in tribunale, in Comune o con la negoziazione assistita);
- sia decorso un anno, se la precedente separazione era stata “giudiziale” (ossia con una causa in tribunale).
Modifica degli accordi
Insieme agli accordi di separazione o divorzio i coniugi possono regolare in Comune anche eventuali modifiche degli accordi di separazione o divorzio precedentemente fissati.
L’iter e le condizioni sono le stesse analizzate sino a qui: pertanto è consentita la modifica degli accordi a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali .
Anche per la modifica è previsto il deposito di un’autocertificazione e due incontri. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.
Se uno dei due coniugi non vuole venire in Comune?
Per la separazione o il divorzio in Comune è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Pertanto, se manchi uno dei due coniugi la procedura suddetta non può essere espletata e non resta che la separazione giudiziale in tribunale.
La negoziazione assistita
La legge prevede anche l’istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap o economicamente non autosufficienti.
L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.
L’invio all’Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. L’invio della documentazione può essere effettuato anche a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
In alcuni Comuni è richiesta la procedura telematica, per cui ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all’ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all’originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).?
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Confessare un tradimento: prova in tribunale
Come dimostrare l’infedeltà coniugale: tutto ciò che non si può fare e che si può fare. Quando la ricerca delle prove di un tradimento diventa reato.
Benché l’infedeltà sia ancora una delle cause più ricorrenti di separazioni tra coniugi, dimostrare un tradimento non è facile. E questo perché, da un lato, le prove che si possono presentare in tribunale devono essere sempre acquisite nel rispetto dell’altrui privacy. E dall’altro perché, il più delle volte, il rapporto extraconiugale si consuma in ambienti chiusi, privi di testimoni. Non resta che la confessione da parte dello stesso coniuge fedifrago. Ma anche in questo caso ci si può imbattere in qualche problema di carattere processuale. Il fatto di confessare un tradimento non vale sempre come prova in tribunale. Ma sul punto sarà bene fare alcune riflessioni rispondendo alle domande più frequenti che si pongono sul tema.
Quali prove di un tradimento?
Dicevamo che dimostrare un tradimento è compito piuttosto arduo. Le prove in un processo civile sono normalmente costituite da documenti e testimonianze oppure dalla confessione fatta in causa dinanzi al giudice. Ma, nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, difficilmente è possibile raggiungere tali risultati.
Per comprendere ciò che stiamo per dire è bene partire da un concetto giuridico cardine di ogni processo: non sono utilizzabili le prove acquisite in violazione della legge e, in particolare, della privacy altrui. Ragion per cui, per dimostrare un tradimento, bisogna agire non in modo scorretto ma nel rispetto delle leggi. Vedremo qui di seguito quali prove non sono ammesse.
Quali prove di un tradimento non sono ammesse in processo
Entrare nell’account social o nelle email del coniuge senza il suo consenso, per spiare il contenuto delle sue conversazioni, è illegale e integra un reato, quello di «accesso abusivo a sistema informatico». Non conta il fatto di aver ricevuto in passato la username e la password per altre finalità: ogni accesso deve essere specificamente autorizzato.
Strappare di mano il cellulare del coniuge per vedere con chi chatta è reato: quello di rapina. Così almeno ha sentenziato più di una volta la Cassazione.
Lasciare un registratore acceso in casa per sentire cosa dice il coniuge quando non si è dentro integra il reato di indebite interferenze nella vita privata. E lo stesso se si attiva un gps e lo si nasconde nell’auto.
Leggere le chat contenute in uno smartphone protetto da password o comunque custodito in un posto riservato è ugualmente reato di violazione della privacy.
Cosa resta da fare? L’unico modo è pizzicare il fedifrago con le mani nel sacco. Come? Ad esempio con una prova fotografica, realizzata magari da un investigatore privato. Quantomeno pedinare una persona, purché non si venga visti e non si generi allarme e preoccupazione nel soggetto in questione, non è reato.
Ma attenzione perché le foto possono essere contestate facilmente, non essendo facile risalire in modo certo alla data (i dati informatici presenti sul file non costituiscono una prova certa).
La confessione di un tradimento vale come prova?
Non resta che sperare in una confessione da parte del traditore. Una confessione che, per avere pieno valore, andrebbe fatta dinanzi al giudice perché solo in questo caso costituirebbe una “prova legale”, ossia certa e inoppugnabile.
Le cose vanno diversamente se la confessione avviene oralmente, nell’ambito di una discussione casalinga, e in assenza di testimoni. Questo perché le dichiarazioni delle parti in causa, ossia dei due coniugi, non possono essere assunte come prova in un processo civile. E quindi il giudice non potrà tenere conto del fatto che il coniuge tradito assuma che, nel corso di una lite, l’altro gli ha rivelato la propria relazione adulterina. Potrebbe registrarlo: e in quel caso la registrazione costituirebbe prova, purché non avvenga in casa. Le registrazioni all’insaputa dei presenti sono infatti lecite a patto che non avvengano nel domicilio del soggetto registrato.
Ultima ipotesi: stimolare la confessione in una chat sul telefonino, ad esempio tramite WhatsApp. E le chat fanno piena prova se colui contro il quale viene prodotta non le disconosce in giudizio. Disconoscimento che non può essere generico ma deve motivare le ragioni concrete per cui la riproduzione della schermata deve ritenersi non genuina.
Proprio di recente il tribunale di Monza si è trovato a giudicare il caso di una confessione di un tradimento fatta dalla moglie al marito in una conversazione su WhatsApp. La moglie è stata inchiodata all’addebito della separazione perché aveva ammesso il tradimento del marito sulla chat. Inutile poi tentare di disconoscere la conversazione, quantomeno sulla certezza della data, per evitare che la relazione extraconiugale confessata fosse ritenuta il fatto scatenante che aveva fatto naufragare il matrimonio. Il contenuto delle conversazioni può essere valutato dal giudice in termini di presunzioni semplici, in quanto gravi, precise e concordanti.
Decisivi, quindi, nel caso si specie, gli estratti dall’applicazione di messaggistica prodotti dal marito: nel tentativo di riappacificarsi con l’uomo al corrente del tradimento la signora aveva ammesso quantomeno di aver «baciato» il collega di lavoro. E i messaggini WhatsApp sono assimilabili agli sms: rientrano nelle riproduzioni meccaniche e fanno piena prova contro colui il quale la chat è prodotta a meno che l’interessato non ne contesti la conformità ai fatti e alle cose rappresentate.
Separazione: come viene assegnata la casa familiare?
Come funziona il diritto di abitazione: quando la casa viene data all’ex moglie e come non perderla. Il caso della coppia convivente e di quella sposata.
La nostra legge prevede che, quando si separano due genitori di figli ancora minori o se maggiorenni non ancora autosufficienti, in mancanza di diverso accordo, il giudice affida la casa al genitore “collocatario”, quello cioè con cui, sempre secondo il giudice, i figli devono andare a vivere giornalmente. A questi viene attribuito il cosiddetto “diritto di abitazione”. Cerchiamo di approfondire il discorso e di vedere come viene assegnata la casa familiare in caso di separazione.
Quando viene assegnata la casa familiare?
Presupposto essenziale per l’assegnazione della casa familiare è che ci sia una coppia con figli che intende separarsi. Non importa se si tratta di una coppia sposata o solo convivente: in entrambi i casi, il giudice può decidere in merito all’attribuzione del diritto di abitazione all’interno dell’immobile che un tempo era il tetto domestico.
Il secondo presupposto per l’assegnazione della casa è che i figli siano ancora minorenni, o portatori di handicap o, se maggiorenni, siano non ancora autosufficienti dal punto di vista economico: il che richiede che stiano ancora studiando o si stiano formando. Diversamente, se il figlio non fa nulla per cercare un’occupazione o, già grande, vive alle spalle dei genitori, non solo non avrà diritto al mantenimento ma il genitore con cui convive perderà il diritto di rimanere nella casa familiare.
Il terzo presupposto per l’assegnazione della casa familiare è che vi sia una procedura di separazione giudiziale. Difatti, un eventuale accordo tra i genitori escluderebbe qualsiasi ingerenza da parte del giudice.
A chi va la casa familiare?
La casa familiare viene assegnata al genitore che, secondo il parere del giudice, è il più adatto a prendersi cura giornalmente della prole. Inutile dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, questo è la madre. È il cosiddetto “genitore collocatario”, concetto completamente diverso da quello di affidamento.
L’affidamento consiste nei poteri-doveri dei genitori di prendere le decisioni più importanti in merito alla crescita, educazione, istruzione, salute dei minori. Di solito, l’affidamento è sempre condiviso: spetta cioè in pari misura sia al padre che alla madre i quali pertanto, quando si tratta di prendere le decisioni di “straordinaria amministrazione” dovranno prima confrontarsi e trovare un’intesa. La collocazione invece non può che avvenire in via preferenziale presso la casa di uno solo dei genitori.
Perché il giudice assegna la casa familiare?
Scopo dell’assegnazione della casa familiare non è un sostegno economico al genitore collocatario ma una tutela in più alla prole, affinché i figli non abbiano cioè a subire un ulteriore trauma, derivante dal trasferimento, oltre a quello della disgregazione del nucleo familiare.
Proprio perché la finalità è quella di tutelare i figli, l’assegnazione della casa familiare avviene sia nei confronti della coppia sposata che di quella di conviventi.
Come funziona l’assegnazione della casa familiare?
Il giudice assegna la dimora familiare e non un immobile qualsiasi: si tratta cioè dell’abitazione ove la famiglia viveva stabilmente prima della separazione. Quindi, in presenza di un nucleo familiare con più abitazioni, il giudice concederà il diritto di abitazione solo nella casa che era dimora abituale della coppia.
Chiaramente, il diritto di abitazione viene dato in pregiudizio del diritto del proprietario dell’immobile che dovrà perciò andare via.
La giurisprudenza ritiene che il diritto di abitazione debba essere concesso anche sulla casa concessa alla coppia in comodato da terzi (ad esempio dai genitori di uno dei due genitori), sempre che il contratto non prevedesse una data di scadenza.
Se l’ex moglie ha già una casa le spetta l’assegnazione della casa familiare
Il giudice può assegnare la casa coniugale alla moglie presso cui vivono i figli anche se questa è titolare di un proprio immobile, ove però la famiglia non viveva.
Come evitare l’assegnazione della casa familiare
L’unico modo per evitare l’assegnazione del proprio immobile all’ex coniuge è di non viverci, ossia di non adibirlo a dimora familiare. Come detto, infatti, il giudice assegna solo la casa ove la coppia viveva stabilmente prima della separazione.
Quando cessa l’assegnazione della casa?
Il diritto di abitazione viene meno quando i figli diventano grandi e possono mantenersi da soli, o quando diventano indipendenti economicamente, o quando decidono di andare a vivere altrove, o quando è lo stesso genitore con cui vivono che si trasferisce. Ma per riottenere il proprio immobile è necessario prima presentare ricorso al giudice affinché modifichi il proprio precedente provvedimento.
Cosa rischia l’amante che rivela la relazione?
Rivelare un tradimento, comunicare al coniuge tradito la propria relazione, diffondere il fatto tra estranei è reato.
Rubare il marito a una donna non è reato. Da un lato, infatti, l’infedeltà non è un illecito penale ma solo civile. Dall’altro lato, tale illecito vale solo per le persone sposate e non per i terzi che ben potrebbero intromettersi in una relazione tra due persone senza per questo violare la legge. L’obbligo di fedeltà, del resto, vale solo per moglie e marito e non per gli estranei la cui libertà sessuale è tutelata dalla legge.
Ci sono però dei casi in cui l’amante può essere denunciata. E ciò succede, il più delle volte, quando è animata da propositi di vendetta. Ad esempio: cosa rischia l’amante che rivela la relazione al coniuge tradito o che la diffonde in pubblico?
La questione è stata oggetto di diverse pronunce da parte della giurisprudenza. Vediamo quando l’amante può essere denunciata.
Denunciare l’amante che entra in casa
Una ormai storica sentenza della Corte di Appello di Cagliari ha condannato l’amante per violazione di domicilio per essere entrata in casa del partner sposato quando il coniuge di questi era assente. La mancanza di consenso da parte del detentore dell’immobile – non importa se non ne sia anche il proprietario formale – integra il delitto in questione e può costare una condanna penale.
Denunciare l’amante che si vendica
Rivelare la propria relazione al coniuge del proprio amante è reato. Inviargli messaggi o chiedergli un appuntamento per svelargli tutto costituisce un illecito penale. Secondo la giurisprudenza, si può sporgere una querela per il reato di molestie. Che di certo non è un reato particolarmente grave ma peserà comunque sulla fedina penale dell’imputato e, dall’altro lato, lo obbligherà a pagare un avvocato per difendersi.
In un caso recentemente deciso dalla Cassazione, è stata condannata una donna che, tramite WhatsApp, aveva inviato alla moglie tradita immagini che testimoniano, in maniera inequivocabile, la concretezza della relazione avuta col marito fedifrago.
A finire sotto processo è una donna, Franca – nome di fantasia –. A farla finire sotto accusa sono alcuni Sacrosanta, secondo i giudici, la condanna per l’amante ritenuta colpevole di molestia ai danni della donna sposata.
Denunciare l’amante che rivela la relazione
L’amante che si confida con un’amica e le comunica la propria relazione con un uomo sposato non è responsabile di alcun reato né di un illecito civile. Ma può essere querelata per diffamazione se il suo comportamento si ripete con almeno due persone. E questo perché, così facendo, mina all’onore e alla reputazione del coniuge tradito e del traditore. Si può sporgere la querela entro 3 mesi da quando si è venuti a conoscenza del comportamento.
Secondo la Cassazione, rivelare in pubblico che una persona tradisce il coniuge è reato di diffamazione. Difatti tali informazioni, anche se fondate, mettono alla berlina sia il traditore che il tradito. Si crea cioè un danno alla reputazione di entrambi i coniugi e della famiglia stessa.
Si possono chiedere i danni all’amante?
Come anticipato in apertura, al di fuori dei reati appena elencati, non si può chiedere all’amante il risarcimento dei danni per aver sfasciato il proprio matrimonio e per aver magari inferto una profonda ferita ai figli. E, del resto, secondo la giurisprudenza, neanche il coniuge traditore deve risarcire il danno al tradito a meno che la relazione adulterina sia avvenuta in modo plateale, dinanzi a tutti, da incidere sulla reputazione di quest’ultimo. Fuori da questo caso isolato (isolato perché, di solito, i tradimenti si consumano in segreto), il traditore va incontro a due sole conseguenze:
- la perdita della possibilità di chiedere il mantenimento, qualora ne avesse avuto diritto per via delle sue condizioni economiche disagiate;
- la perdita dei diritti ereditari sull’ex.
Quali prove in una causa di divorzio
Come vincere una causa di separazione e divorzio: che valore hanno le prove, chi può testimoniare e quali fatti dimostrare al giudice.
Le cause si vincono sulla base delle prove. Non basta avere ragione e affermare il proprio diritto con gran forza. Né è sufficiente avere un avvocato dotato della miglior retorica. E così anche le cause di separazione e divorzio necessitano di prove. Almeno quelle giudiziali, che non si chiudono con un accordo. Ma quali sono le prove in una causa di divorzio e soprattutto a cosa servono? Cosa è necessario dimostrare al giudice? Cerchiamo di fare un passo indietro. All’esito di questo articolo avremo dato al lettore non solo qualche cognizione di diritto processuale ma anche dei validi suggerimenti su come vincere la causa di separazione o divorzio. Ma procediamo con ordine.
Perché la causa di separazione o divorzio?
Separazione e divorzio possono realizzarsi o con l’accordo delle parti oppure nel corso di una causa. Nel primo caso si parla di separazione o divorzio consensuale, nel secondo caso di separazione o divorzio giudiziale.
La procedura consensuale si può realizzare in tre modi diversi:
- dinanzi al giudice (precisamente davanti al Presidente di Sezione), in un’unica udienza il cui questi, dopo aver tentato una (formale) conciliazione tra le parti, dà lettura dell’accordo da queste previamente concordato (per come redatto dai rispettivi avvocati) e lo approva;
- dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune (o davanti al sindaco stesso), in due incontri differenti con una distanza di 30 giorni l’uno dall’altro. Tale possibilità è ammessa solo in assenza di figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti. Inoltre non sono ammessi, nell’accordo, patti di trasferimento di beni (che andranno regolamentati con contratti autonomi). Per sapere di più leggi Separazione e divorzio in Comune: come si fa;
- con un accordo stilato e firmato con l’assistenza dei rispettivi avvocati e da questi poi depositato in tribunale: è la cosiddetta negoziazione assistita.
La procedura giudiziale invece consiste in una causa vera e propria, che inizia con l’atto di ricorso presentato da uno dei coniugi e la difesa successiva dell’altro. Il giudice ammette le prove richieste dalle parti e poi emette la sentenza.
La causa di separazione e divorzio viene intrapresa perché i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su uno o più aspetti dei loro rapporti economici o personali conseguenti alla cessazione del matrimonio. Essa potrebbe pertanto riguardare ad esempio:
- l’ammontare del mantenimento per l’ex coniuge più povero;
- l’ammontare del mantenimento per i figli;
- la collocazione dei figli presso uno dei genitori;
- l’affidamento dei figli (se congiunto o condiviso);
- le modalità di visita dei figli e la possibilità di un coniuge di trasferirsi altrove.
Perché le prove sono necessarie in una causa di separazione o divorzio?
Di solito, le prove sono più importanti nella causa di separazione che in quella di divorzio, dove normalmente il giudice si limita a prendere atto di quanto già era stato deciso nel precedente step della separazione, salvo siano intervenuti eventi nuovi e imprevedibili che abbiano mutato la situazione di fatto (ad esempio, un arricchimento o un impoverimento di uno dei due ex coniugi con conseguente richiesta di incremento o di riduzione dell’assegno di mantenimento; inadeguatezza di uno dei due coniugi ai compiti di genitore, ecc.).
Gli accordi stretti in sede di separazione non sono vincolanti con il divorzio. Ad esempio, se un coniuge, all’atto della separazione, rinuncia al mantenimento in cambio del trasferimento della proprietà di un immobile, con il divorzio potrebbe modificare la propria pretesa e pretendere anche l’assegno.
Di solito, le prove sono volte a dimostrare:
- la responsabilità di uno dei due coniugi nell’aver determinato, con il proprio comportamento, la crisi del matrimonio. Il che ne comporta l’imputazione di addebito, con conseguente perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede legittimario;
- la sussistenza di redditi nascosti e non dichiarati che potrebbero determinare un maggior importo del mantenimento;
- le esigenze economiche del coniuge che richiede il mantenimento o, al contrario, l’incapacità dell’altro di provvedervi per come richiesto dall’ex;
- l’inattitudine di uno dei due coniugi a gestire i figli o a prendere le decisioni più adeguate per la loro crescita. Nel primo caso, la battaglia si concentrerà sulla collocazione dei figli e, nel secondo, sull’affidamento.
Quali prove portare in una causa di separazione o divorzio?
Nel processo civile le prove sono “tipiche” ossia unicamente quelle indicate dal Codice civile. Solo oggi i giudici si stanno aprendo anche alle prove atipiche, come ad esempio le chat, gli screenshot, le email semplici.
Le prove in una causa di separazione o divorzio sono dunque quelle di qualsiasi altro processo. Le elencheremo qui di seguito.
Testimonianza
Possono testimoniare in causa tutti i soggetti, compresi parenti, affini e figli, tranne i due coniugi.
La testimonianza dei minori deve essere disposta con le opportune cautele per tutelare la loro psiche.
Il bambino con più di 12 anni deve essere obbligatoriamente sentito quando si decide sul suo collocamento e affidamento.
Il testimone è solo colui che ha visto i fatti o ne ha cognizione diretta (non sono ammessi i testimoni che hanno conoscenza dei fatti per “sentito dire”).
Le deposizioni dei parenti, affini o figli hanno lo stesso valore probatorio di quelle provenienti da terzi estranei.
È ad esempio frequente, essenzialmente ai fini dell’addebito, la testimonianza:
- dei parenti del coniuge che richiede l’addebito. La prova che la condotta di un coniuge ha determinato l’intollerabilità irreversibile della convivenza può emergere dalle loro testimonianze: i fatti che attengono all’intimità familiare infatti non possono che essere noti con più diretta conoscenza ai congiunti più prossimi;
- dei figli; ad esempio, può essere decisiva la testimonianza del figlio che conferma che la relazione extraconiugale del genitore è stata l’unica causa della crisi che ha portato alla fine del matrimonio.
Il divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali non si applica alla narrazione dei fatti nell’ambito di una testimonianza: tale divieto infatti non può riguardare quelle attività necessarie o obbligatorie per le esigenze di difesa in giudizio quando sono rispettati i limiti della pertinenza e continenza. Il rispetto della privacy non può legittimare una violazione del diritto inviolabile di difesa che non può incontrare ostacoli o impedimenti nell’accertamento della verità.
Documenti e atti
Lettere, scritti, contratti, atti notarili e qualsiasi altro documento può entrare nel processo. Non hanno valore, nel nostro ordinamento, i cosiddetti patti prematrimoniali, quelli con cui le parti concordano in anticipo gli effetti di una eventuale separazione o divorzio. Tuttavia, è possibile che un coniuge si impegni a rimborsare l’altro, in caso di separazione, delle spese da questi sostenute per la ristrutturazione o edificazione della casa comune.
Fotografie
Le foto sono “riproduzioni meccaniche” che fanno fede solo se non contestate in giudizio dalla parte avversaria. Non basta una generica opposizione ma bisogna insinuare nel giudice il dubbio della mancanza di genuinità di tali documentazioni.
Chat, email, screenshot
I giudici ammettono oggi la prova acquisita tramite screenshot, sms, chat ed email a patto che non siano stati acquisiti con l’inganno o in violazione della privacy.
Confessione
La confessione di un coniuge, che può avvenire anche tacitamente (ossia in mancanza di contestazione di un fatto dedotto dall’avversario), è prova legale e vincola il giudice a tenerne conto senza potersi discostare più da esso.
Le indagini della polizia tributaria
Quando è in contestazione il reddito di uno dei due coniugi, l’altro può chiedere al giudice di ricostruire il suo tenore di vita sulla base delle spese da questi sostenute (affitto, viaggi, utenze, ecc.) oppure con una indagine tributaria da affidare alla finanza. In questo secondo caso, si procederà a delle vere e proprie verifiche fiscali.
L’investigatore privato
Spesso, si utilizzano detective privati per dimostrare l’infedeltà di uno dei due coniugi. Il relativo report scritto non è una prova; lo possono essere le foto se non contestate. In ultima analisi, l’investigatore potrà essere sentito come testimone dei fatti a cui ha assistito personalmente.
Separazione con addebito: quali sono le conseguenze
Cos’è l’addebito, cosa comporta e come si fa ad ottenerlo: quali le conseguenze sul mantenimento e sul risarcimento dei danni.
Forse non tutti sanno che, quando interviene la separazione, il giudice non è chiamato a stabilire chi dei due coniugi sia responsabile per la fine del matrimonio se prima non gli viene fatta una esplicita richiesta da una delle due parti. È la cosiddetta richiesta di “addebito”. Ma cos’è l’addebito e quali sono le conseguenze di una separazione con addebito? Possiamo innanzitutto dire che l’addebito è l’imputazione di responsabilità per aver determinato, con il proprio comportamento colpevole, l’intollerabilità della convivenza e aver così fatto naufragare l’unione coniugale. Insomma, subisce l’addebito chi è colpevole di aver dato causa alla separazione.
Addebito però non significa “risarcimento del danno” oppure “obbligo di pagare gli alimenti”. Altre sono le conseguenze dell’addebito. E di tanto parleremo meglio e più diffusamente nel corso del presente articolo.
Cosa significa addebito?
La parola “addebito” è il participio passato del verbo “addebitare” ossia “attribuire la colpa a qualcuno”: in questo caso si tratta della colpa per aver decretato la fine del matrimonio, l’intollerabilità della convivenza.
Intanto il giudice può pronunciare l’addebito a carico di uno dei due coniugi in quanto gli sia stata fatta esplicita richiesta con l’atto di ricorso.
Non è possibile pronunciare l’addebito nel caso di separazione di una coppia di fatto, non sposata, non esistendo, in capo ai relativi conviventi, degli specifici e cogenti obblighi di legge come invece per le coppie coniugate.
Chi subisce l’addebito è colui che viene quindi ritenuto responsabile, a seguito di una regolare causa, della violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio per come elencati dal Codice civile (e di cui a breve parleremo).
Non necessariamente un matrimonio deve terminare con addebito. Come noto, la separazione può essere pronunciata anche su semplice richiesta di una delle due parti, per cause non imputabili alla colpa di uno dei due. Un matrimonio può infatti terminare perché la coppia non va più d’accordo, perché uno dei due non ama più l’altro (non esistendo un obbligo di restare innamorati in eterno) o perché è finita quella comunione materiale e morale che deve sempre legare i coniugi.
La separazione con addebito o senza addebito segue le stesse regole, salvo solo le conseguenze che dall’addebito derivano e di cui parleremo più in avanti nel corso di questo articolo.
Chi stabilisce l’addebito?
A pronunciare l’addebito su una separazione o un divorzio può essere solo il giudice. E pertanto, la dichiarazione di addebito presuppone una procedura di separazione di tipo giudiziale, non consensuale. Quindi, laddove i coniugi riescano a trovare un accordo tra di loro che regoli i loro rapporti personali e patrimoniali dopo l’unione coniugale, non ci potrà essere alcun addebito.
Il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’addebito se nessuna delle parti in causa glielo chiede. Quindi, la richiesta di addebito va fatta con l’atto introduttivo che dà origine alla causa di separazione.
L’addebito viene accertato nel corso della causa, alla luce delle prove addotte dalla parte richiedente e viene sancito con la sentenza che chiude la causa di separazione.
Quando viene dichiarato l’addebito?
L’addebito viene dichiarato solo quando vengono violati gli obblighi di legge derivanti dal matrimonio ossia:
- fedeltà;
- convivenza;
- assistenza reciproca materiale e morale;
- rispetto;
- contribuzione alle esigenze del nucleo familiare.
Tanto per fare qualche esempio pratico, l’addebito viene dichiarato a carico di chi:
- tradisce il coniuge, anche solo virtualmente (ad esempio con una relazione a distanza tramite un social o una chat, senza necessità di contatti fisici);
- va via di casa senza una giusta causa, per un apprezzabile periodo di tempo, o senza l’intenzione di volervi più tornare oppure senza indicare quando tornerà;
- fa mancare al coniuge il proprio sostegno materiale ed economico, come nel caso del marito che, pur lavorando, non provvede alle esigenze economiche della moglie disoccupata;
- umilia, perseguita, svilisce il coniuge, in pubblico o in privato;
- non svolge attività lavorativa o domestica, non contribuendo ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e fisiche.
In secondo luogo, l’addebito può essere dichiarato solo laddove vi sia uno stretto legame di dipendenza tra la violazione di uno dei doveri del matrimonio e la crisi coniugale. Tanto per fare un esempio, intanto si può addebitare la separazione al coniuge fedifrago se è stato proprio il tradimento a determinare la fine dell’unione; ciò non può invece avvenire se il tradimento è solo l’effetto di una crisi già in atto per precedenti motivi (si pensi a una donna che tradisce un uomo che la maltratta, la picchia o che è andato via di casa).
La prova dell'addebito
Il coniuge che richiede l’addebito deve provare che l’irreversibile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell’altro contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Deve inoltre dimostrare l’esistenza di un nesso di causa-effetto tra il comportamento del coniuge e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La prova può essere fornita con ogni mezzo, come ad esempio testimonianze, indizi, documenti, chat, ecc. Non valgono però le dichiarazioni delle parti in causa.
Quali sono le conseguenze dell’addebito?
Erroneamente, si crede che l’addebito implichi un risarcimento del danno o l’obbligo di corrispondere gli alimenti all’ex. Non è così.
L’assegno di mantenimento non dipende dall’addebito ma dalla sproporzione di reddito tra i coniugi, quando questa non dipenda da un atteggiamento colpevole del coniuge meno abbiente. Quindi, anche in una separazione senza addebito, la moglie disoccupata potrà chiedere il mantenimento se dimostra di meritarlo (ossia di trovarsi in tale condizione non già per pigrizia ma per necessità). Dunque, un marito fedele e rispettoso dovrà versare gli alimenti all’ex coniuge.
Quanto invece al risarcimento del danno esso scatta solo quando dall’addebito consegue la lesione di un diritto costituzionale come l’onore o la salute. Si pensi al caso di un tradimento avvenuto in pubblico, con conseguente danno alla reputazione del coniuge tradito; o al marito che picchi la moglie procurandole delle lesioni fisiche e/o un danno psicologico.
Ma allora quali sono le conseguenze dell’addebito? Il coniuge che subisce l’addebito:
- non può ottenere l’assegno di mantenimento, laddove ne abbia diritto, anche se le proprie condizioni economiche non gli consentano di mantenersi da solo;
- non ha diritto alla quota di eredità dell’ex coniuge qualora questi muoia prima del divorzio.
A quest’ultimo proposito è bene ricordare che, con la separazione, i coniugi continuano ad essere l’uno erede dell’altro (salvo appunto per il coniuge che abbia subìto l’addebito), mentre ogni diritto ereditario cessa sempre con il divorzio (indipendentemente dall’addebito).
Come detto, nel caso di evidenti lesioni a diritti costituzionali, l’addebito implica anche un risarcimento del danno che può essere richiesto nello stesso giudizio di separazione. Si tratta tuttavia dell’eccezione, che ricorre in casi particolarmente gravi.
Che succede se entrambi i coniugi sono colpevoli?
Se entrambi i coniugi hanno contribuito a rendere intollerabile la convivenza con comportamenti contestuali e non causalmente connessi, il giudice può addebitare la separazione a entrambi. È il cosiddetto doppio addebito.
In tal caso, il giudice valuta i comportamenti di entrambi i coniugi come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale.
Ad esempio è stato pronunciato il doppio addebito in un caso in cui:
- il marito ha tenuto una condotta violenta che comporta l’addebito, ma l’addebito è stato imputato anche alla moglie in quanto è stata provata una sua relazione extraconiugale;
- la moglie ha accusato il marito, in modo reiterato ed ossessivo, di adulterio e rapporti sessuali con altre persone di famiglia comunicando le accuse a parenti, amici, conoscenti e ai dipendenti del marito;
- moglie e marito si sono traditi reciprocamente e contemporaneamente (diverso sarebbe se un tradimento è successivo all’altro e determinato da ripicca: in tal caso, l’addebito viene pronunciato in capo al primo coniuge che ha commesso tale comportamento).
In caso di doppio addebito non può essere determinato alcun contributo per il mantenimento del coniuge economicamente più debole o meno colpevole.
Il giudice non può effettuare una graduazione fra le diverse responsabilità né fondare il riconoscimento dell’assegno sulla minore rilevanza che il comportamento di uno dei due ha avuto sulla situazione di intollerabilità della convivenza.
In sintesi, possiamo così concludere. Quando l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l’altro coniuge può chiedere la separazione con addebito.
La richiesta deve essere specifica e supportata da prove sulla violazione dei doveri matrimoniali.
Se ne ricorrono le circostanze, il giudice, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile.
Le ragioni che fondano la richiesta di addebito possono giustificare la richiesta di risarcimento dei danni presentata in un giudizio di separazione.
Assegno divorzile all'ex moglie se il nuovo compagno è povero
Come affermato dalle Sezioni Unite, l'assegno divorzile svolge una funzione perequativa e assistenziale, per cui se l'ex moglie è impossibilitata a trovare un lavoro e nonostante la convivenza ha difficoltà, conserva l'assegno
Assegno divorzile all'ex che, anche se convive, non naviga nell'oro
L'assegno di divorzio, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018, ha funzione compensativa, assistenziale e perequativa.
Fatta questa premessa, la ex moglie che, pur convivendo, non ha i mezzi adeguati per mantenersi ed è impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive perché invalida, conserva il diritto all'assegno di divorzio. La convivenza more uxorio infatti non determina in automatico il venire meno della misura. Questo in sintesi quanto emerge dalla Cassazione n. 15241/2022.
La vicenda processuale
In sede di revisione delle condizioni di divorzio il tribunale revoca l'assegno divorzile che era stato disposto in favore della ex moglie. Questa però ricorre in appello, che respinge l'impugnazione in quanto in giudizio è stata accertata la nuova costituzione di una famiglia di fatto e di convivenza more uxorio.
Trascurata la situazione economica dell'ex moglie
- Nel ricorrere in Cassazione la donna, con il primo motivo, evidenza il mancato accertamento da parte della Corte della compatibilità dei fatti nuovi allegati dall'ex marito con il quadro del suo rapporto amicale accertato inizialmente, che non presenta le caratteristiche tipiche dalla famiglia di fatto.
- Con il terzo evidenzia come la corte di appello abbia erroneamente assimilato il nuovo rapporto a una famiglia di fatto nonostante l'assenza della condizione di un progetto di vita con il nuovo compagno. La mera coabitazione con un'altra persona non è sufficiente ai fini della revoca dell'assegno divorzile, in assenza di elementi dai quali è possibile dedurre la formazione di una vera e propria famiglia di fatto.
- Con il quarto inoltre rileva l'omessa considerazione della propria condizione di invalidità e inabilità al lavoro, ricordando al riguardo come la SU della Cassazione n. 18287/2018 abbiano sottolineato anche la funzione solidaristica dell'assegno divorzile.
L'ex inabile e priva di mezzi, anche se convivente, conserva l'assegno
La Cassazione, nel valutare i diversi motivi di doglianza della donna, ritiene fondato solo il quarto motivo, inammissibile invece il primo e infondato il terzo.
Il primo è inammissibile in quanto la Corte di Appello ha dato atto del fatto che l'iniziale amicizia della donna si è trasformata nel tempo in una stabile convivenza more uxorio, sulla base degli elementi probatori a disposizione del giudice e che lo stesso è libero di valutare e scegliere anche in relazione alla loro diversa attendibilità.
Infondato il terzo motivo perché la Corte ha concluso per il nuovo e stabile rapporto di convivenza della donna sulla base degli elementi probatori dai quali è emersa la comune dimora, l'utilizzo della stessa vettura, la suddivisione delle incombenze domestiche, la condivisione della vita di relazione e il rapporto della coppia con i rispettivi membri familiari. Il soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno inoltre, precisa la Cassazione, "può limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato anche dal fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci."
Fondato invece il quarto motivo in quanto in effetti la Corte di merito, nel disporre la revoca dell'assegno, ha solo tenuto conto della nuova convivenza, così contravvenendo a quanto sancito dalle SU in merito alla funzione dell'assegno divorzile, avente natura assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Per cui se l'ex coniuge, che instaura una nuova convivenza è comunque privo di mezzi adeguati e, come nel caso di specie, è impossibilitato a procurarseli, il diritto all'assegno divorzile, in presenza degli altri elementi indicati dalle SU, si conserva.
Madre ostacola il rapporto tra padre e figlio: cosa rischia?
Se un genitore mette un figlio contro l’altro genitore e ostacola le visite perde l’affidamento, decade dalla responsabilità genitoriale e deve risarcire i danni.
Molte coppie separate o divorziate non si rendono conto che il diritto alla bigenitorialità è stabilito in favore dei figli, non dei genitori. Purtroppo, molte madri e tanti padri non sono collaborativi e si oppongono, con vari pretesti, alle visite e agli incontri tra i figli e l’altro genitore che, dopo la separazione o il divorzio, è andato a vivere altrove. Nei casi più gravi, la situazione degenera e c’è chi, approfittando della convivenza quotidiana, cerca di mettere il figlio contro il genitore lontano, tentando di escluderlo definitivamente dai rapporti affettivi.
Così i bambini e i ragazzi coinvolti in queste penose situazioni subiscono continui martellamenti psicologici; diventano “figli contesi” e possono riportare gravi traumi psicologici, con ripercussioni destinate a proseguire anche in età adulta. Ma se una madre ostacola il rapporto tra padre e figlio, cosa rischia?
La giurisprudenza è piuttosto severa in queste situazioni: sono numerose le pronunce che hanno revocato l’affidamento condiviso dei figli e, talvolta, hanno anche dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che ha ostacolato i rapporti e le frequentazioni con l’altro genitore. Inoltre, alle parti lese – che in questi casi sono sia il genitore escluso sia il bambino al quale è stato precluso il rapporto affettivo con lui – viene riconosciuto il risarcimento del danno.
Diritto alla bigenitorialità e affidamento dei figli dopo la separazione dei genitori
I figli hanno il diritto di mantenere un rapporto sereno e costante con i propri genitori: è il loro diritto alla bigenitorialità. Dopo la separazione coniugale, questa esigenza è ancor più accentuata, perché la fine del legame di coppia provoca inevitabilmente un trauma alla prole.
Nelle decisioni sull’affidamento dei figli, i giudici tengono prioritariamente conto della necessità del bambino di sviluppare la propria personalità con l’apporto e il contributo affettivo di entrambi i genitori, che dunque devono continuare a partecipare alla vita dei figli durante la loro crescita. L’affidamento può essere condiviso o esclusivo; in ogni caso, deve garantire la possibilità di frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori.
Di regola, all’esito della separazione e del divorzio si sceglie l’affidamento condiviso, in modo da garantire al figlio una crescita equilibrata con l’apporto sia del padre sia della madre. Con l’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Inoltre, il giudice decide il luogo in cui i figli minori continueranno a vivere; di solito, essi – fermo restando l’affido congiunto – vengono «collocati» presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, per evitare loro l’ulteriore trauma dello spostamento.
Diritto di visita: che succede se viene ostacolato?
In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio stabilisce anche il diritto di visita in favore del genitore non collocatario (che solitamente è il padre), disponendo le modalità, i periodi e gli orari di frequentazione.
A volte, però, accade che le madri ostacolino l’esercizio del diritto di visita, rendendo così più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l’ex coniuge, che è anche il padre del bambino. Le condotte attraverso cui si manifesta questo comportamento sono svariate, così come i motivi che le determinano (astio, risentimento, vendetta, ecc.). I figli diventano così strumentalizzati e manipolati.
A questo punto, il genitore escluso può rivolgersi al tribunale che ha disposto la separazione o il divorzio, lamentando la situazione, esponendo dettagliatamente i fatti accaduti e chiedendo l’adozione dei provvedimenti opportuni per ristabilire i propri diritti. Il giudice ha un ventaglio di opzioni, elencate dall’art. 709 ter del Codice di procedura civile, che comprende:
- l’ammonimento del genitore inadempiente;
- la revoca dell’affidamento condiviso, con il conseguente affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; questo avviene quando l’altro genitore è apparso inadeguato a svolgere i suoi compiti educativi, o quando la sua condotta è tale da costituire serio pregiudizio per la crescita serena ed equilibrata del minore;
- la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore colpevole di aver ostacolato i rapporti del figlio con l’altro genitore; è il provvedimento estremo, adottato quando la condotta ostruzionistica risulta particolarmente grave e non sono praticabili altri rimedi per ripristinare il rapporto tra il figlio ed il genitore escluso;
- il risarcimento dei danni arrecati al figlio ed al genitore con il quale la condotta ostativa dell’altro aveva precluso i rapporti;
- una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro, in base alla gravità della violazione).
Madre ostacola i rapporti del figlio col padre: una vicenda concreta
Applicando i criteri che abbiamo descritto, una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Roma [1] ha dichiarato la perdita della responsabilità genitoriale a carico di una madre divorziata che aveva ostacolato per anni i rapporti del figlio con il padre, arrivando ad inventare malattie inesistenti pur di tenere il minore accanto a sé (questo comportamento è chiamato scientificamente «sindrome di Münchhausen»).
La donna aveva così cercato di instaurare una «pericolosa simbiosi» costruendo un «rapporto patologico» con il ragazzo, un adolescente che aveva raggiunto i 17 anni di età ed era cresciuto isolato e con gravi problemi psicologici. Tutto ciò è risultato «gravemente controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico del minore». Perciò, i giudici capitolini hanno anche disposto il risarcimento dei danni (15mila euro al padre e 25mila euro al figlio), ed hanno disposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per valutare la possibilità di adottare una misura di protezione per il figlio.
Mantenimento ex moglie con lavoro part time: spetta?
L’assegno divorzile deve compensare il sacrificio economico compiuto dalla donna che ha rinunciato al lavoro a tempo pieno per dedicarsi di più alla famiglia.
Immaginiamo una moglie che quando si è sposata aveva un posto di lavoro a tempo pieno, ma poi, dopo il matrimonio, ha optato per il part time. Ha compiuto questa scelta d’accordo col marito, per dedicarsi di più alla famiglia. In seguito, la coppia divorzia e la donna chiede al marito di versarle l’assegno di mantenimento. Sostiene di essersi dedicata alla casa, rinunciando al lavoro a tempo pieno, che le garantiva uno stipendio maggiore di quello che ha percepito con il part-time: perciò, ha avuto ripercussioni economiche negative e chiede che adesso vengano compensate.
Il problema del mantenimento della moglie con lavoro part time si pone frequentemente in questi casi, e può essere visto anche dal lato opposto, cioè considerando che la donna, anche dopo la separazione e il divorzio, mantiene comunque un’occupazione lavorativa remunerata: perciò, l’ex marito potrebbe sostenere che l’ex moglie ha il suo reddito per vivere e non deve essere mantenuta.
Per risolvere questi problemi occorre, innanzitutto, capire come funziona l’assegno divorzile e quando viene riconosciuto: se si tratta o no di una sorta di “buonuscita” per gli anni “spesi” insieme o se ci sono altre condizioni correttive, per evitare che l’emolumento diventi una rendita parassitaria per vivere a carico dell’ex. Poi, bisogna esaminare quali sono le applicazioni pratiche della giurisprudenza, cioè come decidono i giudici in questi casi e quali elementi mettono sul piatto della bilancia.
Mantenimento dell’ex coniuge: condizioni
La condizione essenziale in base alla quale viene attribuito il mantenimento dell’ex coniuge dopo la separazione e il divorzio è l’esistenza di uno squilibrio economico tra le parti: questo indice si misura in base alla disparità dei rispettivi redditi e patrimoni. L’assegno divorzile serve essenzialmente per colmare questa sproporzione.
La funzione essenziale del mantenimento, nella fase di separazione coniugale, è quella di garantire al beneficiario (o alla beneficiaria) il tenore di vita pregresso, quello di cui godeva durante il matrimonio. Con il divorzio, invece, il matrimonio finisce definitivamente, e l’assegno serve a fornire l’aiuto economico necessario all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi da sé. Ecco, allora, che il lavoro svolto dalla ex moglie può diventare un elemento decisivo, in quanto fornisce un reddito, che è anche tendenzialmente stabile, quando si tratta di un’occupazione a tempo indeterminato.
Mantenimento ex coniuge che lavora
La legge sul divorzio si limita a dire che: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Questa formulazione lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nel decidere la misura dell’assegno divorzile. Il criterio della disparità fra i redditi dei due ex coniugi viene contemperato con l’incapacità di uno dei due di mantenersi autonomamente. Questa incapacità, però, deve essere oggettiva ed incolpevole; perciò l’assegno non viene riconosciuto a chi potrebbe lavorare e non lo fa. Viceversa, se la donna è in età avanzata, o soffre di patologie invalidanti, o è priva di istruzione e qualificazioni professionali, l’inserimento nel mondo del lavoro diventa impossibile e l’assegno le spetta.
Assegno divorzile alla ex moglie che lavora part-time
Oltre ai criteri generali che abbiamo esaminato e che costituiscono le condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile, la giurisprudenza più recente aggiunge il contributo che l’ex coniuge aveva dato al ménage familiare. Sono frequentissimi i casi di donne che si sono sacrificate per la carriera del marito rinunciando, così, alla propria attività lavorativa o riducendola sensibilmente per dedicarsi alla casa e alla crescita dei figli.
In questi casi, l’ex moglie ha diritto di vedersi riconosciuta questa forma di partecipazione all’andamento della famiglia, specialmente se il matrimonio ha avuto una lunga durata e il sacrificio si è protratto per parecchi anni, al termine dei quali la donna divorziata, ormai, non ha più l’età e le energie per tentare un reinserimento lavorativo pieno (abbiamo parlato di questi aspetti nell’articolo “Mantenimento ex moglie che ha rinunciato alla carriera“).
Considerando le cose da questo punto di vista, ecco che il contributo fornito dalla donna alla famiglia nel corso degli anni diventa “monetizzabile” al momento del divorzio, in quanto è suscettibile di valutazione economica. E infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’assegno divorzile non ha soltanto una funzione assistenziale, ma anche una finalità «perequativa e compensativa» che tende ad eliminare, o almeno ad attenuare, gli squilibri economici esistenti tra gli ex coniugi e valorizza i comportamenti tenuti in ambito familiare, compresa l’attività di casalinga.
In questa prospettiva, una recentissima ordinanza della Suprema Corte ha riconosciuto alla ex moglie l’assegno divorzile, tenendo contro che ella durante gli anni di matrimonio aveva «apportato un rilevante contributo economico alla famiglia attraverso la conversione del rapporto di lavoro in part-time, d’accordo col marito». Prima questa signora lavorava a tempo pieno, come nell’esempio che abbiamo fatto all’inizio dell’articolo. In definitiva, quando si ravvisano tali situazioni anche con il lavoro part-time si prende il mantenimento.
Affidamento condiviso "quasi perfetto"
Arriva dal tribunale di Genova, un affidamento condiviso pressoché paritetico tra i genitori di una bambina in tenerissima età.
Affidamento "quasi perfetto": la decisione del Tribunale di Genova
L'affidamento condiviso, secondo la legge n. 54/2006 è la regola, ma raramente viene applicato in modo "quasi perfetto" come ha fatto il Tribunale di Genova con il decreto del 29 aprile 2022. Pienamente soddisfatto della decisione il difensore del padre, l'Avv. Simone Marchetti, che evidenzia la vittoria della bambina in questo caso, che potrà così trascorrere lo stesso tempo con la mamma e il papà. La tenerissima età della bambina (appena tre anni) e la conflittualità tra i genitori, come nel caso di specie, non sono da ostacolo all'affidamento condiviso, perché l'equilibrio psicologico ed emotivo della bambina non sono messi a rischio, se così non fosse, tale forma di affidamento sarebbe solo residuale.
La vicenda
Una madre si rivolge al Tribunale di Genova per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore, del regime di collocamento della stessa, delle modalità di frequentazione dei genitori e dei collegati aspetti economici.
La donna dichiara di aver avuto una relazione con il resistente, da cui è nata una bambina e che dopo il ritorno della stessa a Genova, dove vive la sua famiglia, sono insorti forti contrasti per la gestione della figlia e che l'ex compagno non ha più versato nulla per il mantenimento.
La donna richiede quindi un contributo per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie e regole precise per quanto riguarda le modalità di frequentazione della stessa.
Il resistente contesta in parte la versione dei fatti narrata dalla ex compagna, fa presente di aver preso un appartamento a Genova per frequentare la figlia, potendo gestire il suo lavoro anche online e che lo stesso ha sempre trascorso molto tempo con la bambina.
Chiede che nel rispetto della bigenitorialità gli sia consentito di continuare a frequentare la bambina anche tramite il riconoscimento di un affidamento condiviso con tempi paritetici e mantenimento diretto da parte dei genitori.
Affido condiviso con tempi quasi paritetici
L'adito Tribunale di Genova accoglie in sostanza la richiesta del padre, ricordando che dopo la Legge n. 54/2006 l'affidamento condiviso rappresenta la regola.
Nel caso di specie, dispone infatti un affidamento "quasi perfetto" che prevede in sintesi il diritto della bambina di trascorrere, mensilmente, 16 notti con la madre e 12 con il padre. Feste civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, mentre nel periodo estivo la bambina potrà trascorrere 15 giorni consecutivi solo con la mamma e 15 solo con il papà. In presenza di problemi lavorativi che dovessero alterare il regime di visita è previsto che il genitore interessato avverta l'altro con un congruo anticipo così da consentirgli di organizzarsi.
La Cassazione, del resto, ha chiarito che la conflittualità non impedisce l'affidamento condiviso, altrimenti tale regime avrebbe un'applicazione residuale, mentre il minore ha diritto a trascorrere lo stesso tempo con mamma e papa in modo continuativo ed equilibrato.
La bambina quindi va affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori e, appurate le condizioni economiche di entrambi, dispone che il padre versi alla madre 250 euro mensili per il contributo al mantenimento della bambina.
Nell'affidamento condiviso vincono i figli
L'avvocato Simone Marchetti, difensore del padre, commenta positivamente e in questi termini la decisione del Tribunale del capoluogo ligure: "Si tratta di un provvedimento di assoluto buon senso e che va nella giusta direzione, intrapresa dalla giurisprudenza negli ultimi mesi. Il cosiddetto affido condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento già nel 2006 e, pertanto, quindici anni orsono. In questo lungo periodo, tuttavia, la legge, assolutamente condivisibile nella sua ratio ispiratrice, si è però scontrata con la prassi, diffusasi nelle aule di giustizia, dell'affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Con il decreto di cui parliamo, invece, il Tribunale di Genova si è dimostrato al passo con i tempi ed ha ritenuto corretto, nell'interesse della minore, il collocamento sostanzialmente paritetico tra i genitori. Non pare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, non ha vinto il padre (che rappresento) ed ha perso la madre. Nel diritto di famiglia e minorile la prospettiva è diversa: in questa specifica situazione ha vinto, per così dire, la bambina che aveva ed ha diritto di stare sia con la mamma sia con il papà".
Mantenimento dell'ex partner in una nuova relazione
Stop all'assegno divorzile se l'ex ha una relazione stabile, anche senza coabitazione
La nuova convivenza dell'ex coniuge, beneficiario dell'assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, anche senza coabitazione.
La convivenza more uxorio non esige la coabitazione
Sul rilievo della nuova convivenza dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile ai fini della revoca dello stesso arriva una Cassazione, che farà sicuramente discutere. Vine rimesso in discussione il concetto di convivenza che per gli Ermellini non va confuso con la coabitazione. Ai fini della convivenza more uxorio infatti non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto affettivo e materiale spontaneamente.
Nel caso di specie in effetti la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile ha trascurato il fatto che il nuovo compagno è considerato dalla ex moglie come suo fidanzato, che lo stesso si rechi abitualmente a casa della donna e che paghi le utenze dell'energia a lui intestate. Valuti meglio la Corte in sede di rinvio tutti gli elementi probatori prima di escludere la convivenza di fatto rilevante ai fini della revoca dell'assegno di divorzio. Questo quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 14151/2022.
La vicenda processuale
Un ex marito chiede la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della ex moglie dal Tribunale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda però viene respinta perché non risulta provata la nuova convivenza della ex moglie e la dedotta disoccupazione del richiedente. L'uomo appella la decisione perché ritiene di aver provato il suo licenziamento e la nuova convivenza della ex moglie, chiedendo di ammettere testimoni sul punto.
La Corte di Appello conferma però la decisione di primo grado anche perché il licenziamento non rileva ai fini del modesto importo dell'assegno divorzile. Per quanto riguarda invece la nuova convivenza della ex moglie la Corte precisa che la stessa avrebbe rilievo ai fini della revoca se rappresentasse una situazione capace d'incidere sulla situazione reddituale della beneficiaria.
Il nuovo compagno con coabita ma è convivente
Nel ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello l'ex marito fa presente che la sola prova della instaurazione di una convivenza stabile da parte dell'obbligato a corrispondere l'assegno sia sufficiente ai fini della domanda di revoca dell'assegno, dovendo piuttosto la beneficiaria, in questo caso, dimostrare che la nuova convivenza non è tale da rappresentare la formazione di una nuova famiglia.
Fa poi presente che in sede di merito, dalla testimonianza della figlia, è emerso che in realtà la sua ex moglie ha una relazione stabile, che il nuovo compagno in diverse occasioni è stato visto a casa della madre, tanto da ritenere la sua presenza nella vita della donna non occasionale. Non solo, l'utenza dell'energia elettrica dell'abitazione della donna è intestata al nuovo compagno, giustificata per motivi di comodo dovuti a una riparazione. Circostanza che però la Corte di Appello non ha ritenuto erroneamente capace di dimostrare la stabile convivenza dei due soggetti.
Nel ricorso quindi l'uomo lamenta la violazione di legge per quanto riguarda il significato di "convivenza", la mancata valutazione della confessione della ex moglie, la violazione del principio di necessità di valutare globalmente gli indizi e infine l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla confessione stragiudiziale di un terzo.
La convivenza va distinta dalla coabitazione
Il ricorso, con il quale vengono sollevati complessivamente 5 motivi, viene accolto perché gli stessi, esaminati congiuntamente, sono fondati.
Per la Cassazione occorre distinguere prima di tutto i concetti di coabitazione e convivenza more uxorio.
Dopo avere richiamato normativa e giurisprudenza relative al significato dei due termini, la Corte giunge alla conclusione che la convivenza giuridicamente è definita in sostanza come un legame tra due soggetti maggiorenni, uniti da un rapporto stabile di natura affettiva e di reciproca assistenza morale e materiale spontanea e reciproca. Del resto la legge stessa prevede che le coppie conviventi possano, non debbano, indicare un a residenza comune. Entrambi infatti hanno la possibilità di conservare due dimore distinte. La coabitazione di conseguenza ha valore indiziario in relazione alla prova dell'esistenza di una convivenza di fatto.
Superficiale a atomistica risulta inoltre la valutazione degli elementi istruttori da parte della Corte di Appello. Dall'istruttoria è infatti emerso che la donna considera il nuovo compagno come suo fidanzato e che lo stesso è presente in modo stabile nella vita della donna.
Il decreto va pertanto cassato e rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "in materia di revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente, ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale."
Chi tradisce deve pagare i danni?
Infedeltà: effetti sul mantenimento e sul risarcimento a carico del coniuge traditore.
Di solito, chi rompe paga. Ma se a rompersi è il matrimonio, vale la stessa regola? Se una coppia, dopo qualche anno di matrimonio, dovesse separarsi perché uno dei due scopre che l’altro lo tradisce e, a seguito di ciò, il coniuge tradito dovesse cadere in uno stato di profonda depressione, perdere il lavoro, rinunciare alla propria vita sociale, magari pagare una lauta parcella a uno psicanalista per uscire fuori dalla situazione che lo opprime, potrebbe chiedere il risarcimento all’ex? In altri termini, chi tradisce deve pagare i danni? La questione è finita non poche volte sul banco della Cassazione. Ecco quali sono le risposte fornite dai giudici a tale situazione.
Il tradimento comporta responsabilità?
La fedeltà è un obbligo solo per le coppie sposate e per quelle unite in unione civile. Giammai, in una coppia di conviventi, un partner potrebbe accusare l’altro di infedeltà.
Ma anche all’interno del matrimonio, le conseguenze dell’infedeltà sono ridotte al minimo. Più in particolare, chi tradisce non può più chiedere l’assegno di mantenimento all’altro, né può rivendicare diritti ereditari qualora l’ex dovesse morire prima del divorzio (con il divorzio, invece, indipendentemente dal tradimento, si perde in ogni caso la qualità di erede legittimario).
Tutto ciò viene sintetizzato in un’unica frase: l’infedeltà comporta l’addebito, ossia l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio. Una responsabilità di natura civile, come appena visto, e non già penale. In buona sostanza, tradire non è più – come un tempo lo era solo per la donna – reato.
Quando il tradimento è lecito?
Abbiamo detto che il tradimento implica l’addebito, ossia la perdita del diritto al mantenimento e all’eredità. Tale conseguenza può discendere però solo da un’eventuale causa di separazione (non deve quindi esserci una procedura di separazione consensuale) e da un’esplicita richiesta presentata dal coniuge tradito al giudice. Questi deve inoltre fornire due importanti prove: innanzitutto, deve dimostrare l’altrui infedeltà e, in secondo luogo, che proprio a causa di questa la convivenza è divenuta impossibile. In buona sostanza, il coniuge tradito deve provare che la fine del matrimonio è derivata unicamente dalla scoperta dell’adulterio e non da precedenti e differenti cause.
Ragion per cui, in una coppia già alla deriva, dove i coniugi litigano spesso, non vanno d’accordo, o magari non convivono più, oppure hanno già deciso di separarsi, il tradimento non implica l’addebito: esso infatti non è la causa della fine del matrimonio ma l’effetto di una causa pregressa.
Il tradimento non è un illecito quindi se commesso dalla moglie che è stata abbandonata dal marito o che da questi viene continuamente vessata e umiliata; oppure da un marito che ha da poco scoperto il precedente tradimento della moglie e non sia riuscito a perdonarla.
Chi tradisce deve risarcire?
Chi viene tradito ha dunque tutto l’interesse a dimostrare l’altrui infedeltà, non dovendo così versare alcun mantenimento all’ex.
Tuttavia, oltre all’addebito – ossia all’impossibilità di chiedere il mantenimento e di rivendicare la quota dell’eredità dell’ex – il tradimento non ha ulteriori effetti. Dunque, chi tradisce non deve pagare il risarcimento all’ex, neanche se questi dimostra di aver sofferto danni morali (la depressione) o economici (ad esempio le spese per il matrimonio o quelle sostenute per la gestione familiare; la perdita del lavoro conseguente a uno stato di angoscia).
C’è una sola ipotesi – secondo la Cassazione – in cui il tradimento implica il diritto a ottenere il risarcimento: quando esso si risolve in una lesione all’onore e alla reputazione dell’ex. Il che avviene tutte le volte in cui l’infedeltà si consuma in pubblico, alla luce del sole, dinanzi a tutti: quando cioè il coniuge fedifrago non fa nulla per nascondere la propria relazione adulterina.
In tale ipotesi, poiché il fatto di “avere le corna” è percepito come un disvalore sociale e una fonte di vergogna, la vittima di tale comportamento può chiedere i danni morali. A nessuno piace sapere che gli amici o i colleghi di lavoro gli parlano alle spalle, sapendo come la sua relazione sia naufragata. Ecco, in questi casi, vi è certo una lesione alla propria reputazione che va risarcita.
Chi tradisce deve pagare il mantenimento?
Spesso, si cade in errore e si ritiene che chi tradisce debba pagare gli alimenti all’ex. Non è corretto. Il versamento dell’assegno mensile di mantenimento non è una conseguenza del tradimento o comunque una sanzione per la violazione degli obblighi matrimoniali. Esso scaturisce unicamente dalla disparità di reddito tra i due coniugi, disparità non dovuta a una colpa di chi chiede l’assegno.
Pertanto, se i due coniugi hanno un reddito simile, il coniuge traditore non dovrà versare il mantenimento all’ex, nonostante la sua condotta colpevole. Se uno dei due coniugi ha un reddito superiore all’ex, questi dovrà versargli il mantenimento anche se è sempre stato fedele. Se il coniuge traditore ha un reddito più basso dell’ex non dovrà versargli il mantenimento.
L’unica ipotesi quindi in cui il tradimento determina effetti sugli alimenti è quando a tradire è il coniuge con il reddito più basso: questi non potrà rivendicare il mantenimento per sé.
Fino a quando sono dovuti gli alimenti al figlio?
Quando un figlio raggiunge l’indipendenza economica e cosa si intende con questo termine?
Dopo la laurea, il figlio perde gli alimenti? Quando si può smettere di dare il mantenimento ai figli? La risposta è stata ampiamente fornita dalla giurisprudenza. Secondo i giudici, il giovane perde il diritto al mantenimento sia quando raggiunge una sua indipendenza economica, sia quando, superata una certa età, sia ancora disoccupato. E questa età è rapportata al tipo di percorso di studi che ha prescelto. Chi quindi ha deciso di non studiare, dovrà subito darsi da fare per cercare un impiego o una propria autonomia; chi invece ha intrapreso un corso universitario, che magari richiede anche una successiva specializzazione, avrà più tempo a disposizione. Ma non si può ritenere che, a trent’anni suonati, si debba stare ancora a carico della madre e del padre.
Ecco allora alcuni importanti chiarimenti in materia di mantenimento ai figli.
Fino a quando i genitori devono tenere in casa i figli?
I genitori, benché separati, devono garantire ai figli non solo il vitto e l’alloggio, ma anche lo stesso tenore di vita di cui essi stessi godono. Sicché, devono dar loro la possibilità di proseguire gli studi (anche universitari e post universitari); devono far fronte alle esigenze relazionali e ludiche tipiche dei ragazzi (gite scolastiche, mezzi di trasporto, computer, centri sportivi, ecc.).
Quindi, un genitore non può mandare via di casa il figlio fino a quando questi è incapace di provvedere a se stesso.
Fino a quando i genitori devono mantenere i figli?
Anche se separati, i genitori – ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche – devono mantenere i figli sino a quando questi non raggiungono l’indipendenza economica o, benché disoccupati, non hanno un’età tale da ritenere che l’assenza di lavoro sia dovuta a pigrizia.
Vediamo singolarmente queste due ipotesi.
Quanto all’indipendenza economica, questa si raggiunge con un reddito certo, ma non necessariamente elevato o in linea con le ambizioni del giovane. Quindi, se il figlio inizia a guadagnare da attività parallele rispetto a quello che è il proprio “sogno” perde il mantenimento.
Non si deve trattare ovviamente di un contratto stagionale o di uno a tempo determinato per pochi mesi, senza possibilità di rinnovi. Ma anche un part-time o un assegno di ricerca potrebbe essere sufficiente a perdere il mantenimento. Non basta invece un contratto di formazione professionale.
Una volta raggiunta l’indipendenza economica, il figlio perde per sempre il mantenimento anche se poi perde il lavoro dopo poco.
Quanto invece all’età, il ragazzo deve fare in modo di rendersi indipendente dai genitori in due modi: o formandosi (e quindi studiando con profitto) oppure cercando un lavoro. Se il giovane decide di non proseguire gli studi, dovrà subito mettersi alla ricerca di un’occupazione. Se invece opta per la laurea, dovrà superare gli esami e far in modo di non perdere tempo nei corridoi dell’ateneo. Una volta laureato avrà l’obbligo di cercare lavoro.
Superati i 30 anni, al padre non è neanche richiesto dimostrare l’inerzia del figlio nella ricerca del lavoro: dopo una certa età, si presume lo stato di disoccupazione colpevole.
Dopo la laurea il figlio perde il mantenimento?
Non spetta l’assegno di mantenimento al trentenne laureato che deve trovarsi un lavoro qualsiasi. E, oltre a ciò, la madre perde il diritto di abitazione nella casa dell’ex.
Finito il percorso di studi, è l’autoresponsabilità a imporre al figlio maggiorenne di cercare un’occupazione anche fuori dal campo prescelto.
A trent’anni, il figlio ormai laureato deve definitivamente emanciparsi dai genitori, iniziando a trovarsi comunque un lavoro, quindi anche al di fuori del campo di studi prescelto, se il mercato non offre altre opportunità.
Il figlio che chiede l’assegno – o per lui il genitore convivente – deve dimostrare che la preparazione professionale o tecnica è stata perseguita con ogni possibile cura e che altrettanto impegno è stato profuso nella ricerca di un’occupazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Cassazione ormai chiede che il giovane ridimensioni, se del caso, le proprie aspirazioni senza aspettare un’opportunità consona alle proprie ambizioni: deve dunque fronteggiare il mercato del lavoro, vi siano o no occasioni nel settore del campo di studi prescelto. Insomma: giunto ai trent’anni deve trovare una qualsiasi attività che produca reddito perché non è possibile che sia ancora mantenuto dalla famiglia.
Quando si può essere incriminati per atti osceni
Cosa si intende per atti osceni, per luogo pubblico e per luoghi abitualmente frequentati da minori.
Gli atti osceni in luogo pubblico costituivano, un tempo, reato. Nel 2016, tale comportamento è stato depenalizzato. Oggi, pertanto, si viene punti con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 30.000 euro.
Tuttavia, residuano ancora alcune ipotesi in cui tale comportamento continua a costituire illecito penale. E, poiché in proposito la legge è piuttosto generica, bisogna rifarsi alle indicazioni della Cassazione per comprendere, con maggiore precisione, quando gli atti osceni sono reato.
Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico?
La legge non dice cosa si debba intendere per «atti osceni». La giurisprudenza ha chiarito che non si tratta solo dell’atto sessuale in sé (si pensi alla coppietta) o dei preparativi all’atto stesso (toccamenti e simulazione, con esclusione dei soli baci), ma anche del toccamento lascivo di parti intime del proprio corpo, sia pure al di sopra dei vestiti. L’autoerotismo è quindi un atto osceno.
Anche l’esibizione in pubblico degli organi genitali rientra negli atti osceni e, in generale, qualsiasi comportamento esibizionistico attinente alla sfera della sessualità (si pensi a una persona che guidi completamente nuda o al passeggero che sporga le natiche alle altre auto, sia pure in gesto di scherno).
Più in generale, bisogna ricomprendere negli atti osceni, qualsiasi attività in grado di offendere il sentimento della morale sessuale e del pudore così da destare, in chi possa assistervi, disgusto e repulsione. A fronte di tale accezione molto ampia, c’è anche chi sostiene un’interpretazione più restrittiva, facendovi rientrare solo quell’attività che, di per se stessa, sia «gravemente lesiva» del pudore pubblico.
Esempi di atti osceni
A titolo di esempio, va ricordato che sono stati, in questi ultimi anni, ritenuti atti osceni e puniti come tali: il coito commesso in un giardino pubblico, la masturbazione commessa in una biblioteca pubblica; l’aver mostrato i genitali a una ragazza, standosene seduto in automobile ferma sulla pubblica via; l’aver toccato (sia pure al di sopra degli abiti) parti intime del corpo di una ragazza consenziente (se non fosse consenziente, si integrerebbe il reato di violenza sessuale).
Vetri appannati: è reato di atti osceni?
Gli atti osceni sono stati esclusi invece nel caso di chi ha avuto rapporti carnali con una donna in un’autovettura i cui vetri erano appannati al punto tale da non permettere di vedere cosa stesse accadendo all’interno, oppure i cui vetri erano stati accuratamente coperti dall’interno con stoffa o giornali.
Atti osceni: cosa si intende con “luogo pubblico”?
Elemento essenziale per punire gli atti osceni è che essi avvengano in luogo pubblico. Gli atti osceni consumati in casa propria o in un luogo privato (ad esempio un circolo) non costituiscono illecito.
È luogo pubblico quello continuamente libero e accessibile, di diritto o di fatto, a tutti o a un numero indeterminato di persone. Lo è ad esempio un vicolo cieco, un cunicolo di collegamento di due gallerie di autostrada, il ponticello sotto la ferrovia.
Si rientra negli atti osceni anche nel caso in cui l’azione si consumi nell’auto parcheggiata in orario notturno in una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l’eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti. Bisognerebbe avere allora l’accortezza di oscurare i vetri con giornali.
Il luogo è pubblico anche se completamente deserto, come un bosco. Conta la possibilità astratta che chiunque possa venire, per quanto remota sia tale possibilità.
È stato altresì escluso che possa essere ritenuto un luogo pubblico un’aperta campagna di proprietà privata e lontana da strade e da case.
Quando gli atti osceni sono reato?
Gli atti osceni continuano ad essere reato quando sono consumati in luoghi abitualmente frequentati da minori o nelle immediate vicinanze.
Secondo la Cassazione, vi sono due tipi di luoghi abitualmente frequentati da minori:
- quelli per vocazione strutturale;
- quelli per elezione specifica (ossia perché divenuti, convenzionalmente, luogo di ritrovo di minori).
Nella prima categoria troviamo, ad esempio, la scuola, o il cortile di questa, una sala giochi, un campetto di calcio, i luoghi di formazione fisica e culturale, gli impianti sportivi, le ludoteche, i giardini muniti di giostre per i bambini, di scivoli e altalene.
Secondo la giurisprudenza, invece, non è un luogo abitualmente frequentato da minori un parco pubblico dove non vi sono appositi spazi ricreativi per bambini.
Nella seconda categoria troviamo invece quei luoghi che, di volta in volta, sono scelti dai minori come punto di abituale incontro o socializzazione ove si trattengono per un termine non breve. Gli esempi possono essere: un muretto sulla strada pubblica, il parcheggio di un centro commerciale, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale, le strade e le piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, quella parte dei giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli (ad esempio per la presenza di una pista di pattinaggio o un campetto di pallavolo, o con uno stagno e le anatre), ivi comprese le zone ad esse limitrofe.
Cosa si intende per luogo abitualmente frequentato da minori
Come abbiamo appena visto, gli atti osceni, normalmente illecito amministrativo, diventano reato solo quando compiuti in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze. Oltre a tutti gli esempi appena fatti nel paragrafo precedente, è bene ricordare che, secondo la Cassazione, per «luogo abitualmente frequentato da minori» non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.
Il fatto che, in un vagone del treno o su una strada di città, possano potenzialmente trovarsi bambini non ne fa luoghi “abitualmente frequentati da minori”. Pertanto, in tali casi, non si verifica il reato ma si rientra nell’ambito dell’illecito amministrativo.
Assegno divorzile alla ex che dimostra le rinunce professionali
Cassazione: la differenza reddituale tra ex coniugi e la prova che la condizione reddituale deteriore della moglie è conseguenza delle rinunce ad occasioni lavorative migliori giustificano l'assegno divorzile
Assegno di divorzio
La ex moglie che lavora da anni, che percepisce uno stipendio assai inferiore rispetto alla pensione del marito e che in giudizio dimostra di aver rinunciato a occasioni di lavoro più redditizie per far fronte ai bisogni della famiglia, deve essere compensata per i sacrifici fatti. Queste le motivazioni che hanno portato la Cassazione, con l'ordinanza n. 12800/2022, ad accogliere il ricorso di una ex moglie a cui, in sede di appello, è stato negato l'assegno di divorzio.
Negato assegno di divorzio alla ex moglie
In sede di appello viene respinta l'impugnazione della ex contro la parte della sentenza di divorzio che le ha negato il riconoscimento dell'assegno di divorzio nella misura di almeno 400 euro.
Per il giudicante, stante la natura composita dell'assegno divorzile, ossia compensativa, perequativa e assistenziale, tra i due coniugi non è presenta una disparità economica tale da giustificare l'assegno anche perché la moglie lavora e di fatto è economicamente autosufficiente. In ogni caso il divorzio attenua il vincolo di solidarietà familiare.
Disparità e rinunce legittimano l'assegno
La moglie ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte sollevando due motivi di doglianza.
- Con il primo contesta della decisione della Corte di averle negato il riconoscimento dell'assegno basandosi solo sulla mancanza di differenza reddituale tra i coniugi.
- Con il secondo invece invoca la nullità della sentenza per non aver tenuto conto, nonostante le prove documentali, della effettiva differenza economica tra i coniugi, visto che il marito ha una pensione di 2300 euro (ed è titolare di un immobile), mentre la stessa ha uno stipendio di 1135,00 euro (e deve pagare il canone di locazione dell'immobile in cui vive) e che la stessa ha rinunciato per la famiglia a occasioni di lavoro più redditizie.
Vanno compensate le rinunce professionali fatte per la famiglia
La Cassazione accoglie il ricorso in quanto i motivi sollevati dalla ex moglie, trattati unitamente, sono fondati.
Dopo avere richiamato i principi in materia di assegno divorzile della SU n. 18287/2018 la Cassazione evidenzia come la Corte d'appello, dopo avere richiamato la natura composita dell'assegno, abbia poi negato la misura sostenendo che con il divorzio il vincolo di solidarietà si attenui e che nel caso di specie, poiché non vi è una disparità reddituale l'assegno divorzile non spetti alla ex moglie.
Al riguardo la Cassazione fa presente che nel caso di specie la Corte abbia in realtà trascurato il fatto che la donna si sia trovata in una situazione reddituale deteriore rispetto al marito, dimostrando con prove documentali la rinuncia della stessa a occasioni di lavoro migliori per contribuire ai bisogni della famiglia, con un sacrificio di tipo economico, che deve essere compensato.
Occorre quindi riconoscere alla ex un assegno di divorzio tale da garantirle autosufficienza e indipendenza secondo un criterio di normalità, compensandola per il sacrificio e per le rinunce a occasioni professionali e reddituali fatte per la famiglia.
Mantenimento ex partner che non cerca lavoro
Se la ex moglie non cerca occupazione l’assegno può essere eliminato o ridotto, ma non se aveva sacrificato le sue aspettative per agevolare la carriera del marito.
L’assegno di mantenimento non è, o non dovrebbe essere, una rendita parassitaria per continuare a vivere a carico dell’ex coniuge. Questo principio è stato affermato spesso dalla giurisprudenza, specialmente nelle pronunce più recenti; ma ogni volta bisogna ricorrere al giudice, mentre spesso il beneficiario dell’assegno è uno “scansafatiche”, che si culla sugli allori della cifra mensile percepita e non si dà da fare per trovare un’occupazione lavorativa. Così molti mariti, costretti a pagare praticamente vita natural durante, si chiedono: se la mia ex moglie non cerca lavoro, va mantenuta?
Per prima cosa va tenuto presente che molte donne sono rimaste a casa per anni durante il matrimonio, dedicandosi alla famiglia ed alla crescita dei figli. Per loro è molto difficile ricollocarsi sul mercato del lavoro, specialmente se non sono più giovani. Qui, però, ci concentriamo soprattutto su coloro che potrebbero ottenere un impiego, ma non si adoperano in tal senso e restano inerti: nonostante i titoli di studio posseduti o le capacità professionali conseguite, non presentano curriculum, non partecipano a concorsi e selezioni, non formulano proposte di nessun tipo ad eventuali datori di lavoro che potrebbero assumerle.
E intanto l’ex coniuge ogni mese continua a staccare l’assegno di mantenimento, nella misura inizialmente stabilita d’intesa tra le parti o dal giudice; che di solito è consistente, proprio in considerazione dello stato di disoccupazione del beneficiario, e, quindi, del suo bisogno economico. Sono proprio questi i casi in cui si pone in maniera forte la domanda: se l’ex moglie non cerca lavoro, va mantenuta? Vediamo.
Quando bisogna mantenere l’ex moglie?
Il marito deve mantenere l’ex moglie se e fino a quando c’è un rilevante divario economico tra i due ex coniugi. Questo squilibrio si misura in base alla disparità dei rispettivi redditi e patrimoni. Nella maggior parte dei casi, al momento della separazione o del divorzio, è il marito a percepire il reddito più alto, o l’unico reddito, se la moglie è casalinga. Allora, l’assegno di mantenimento viene attribuito per colmare questa sproporzione.
Tuttavia, nella determinazione dell’ammontare spettante c’è una profonda differenza tra l’assegno di mantenimento, che sorge a seguito della separazione coniugale, e l’assegno divorzile. Il primo emolumento è una “misura tampone”, che serve a garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio;
invece l’assegno divorzile – che ha carattere più stabile, in quanto interviene dopo la cessazione definitiva del matrimonio – deve fornire un aiuto economico all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi da sé, autonomamente, con le proprie fonti reddituali e patrimoniali. Ha, quindi, una funzione che la giurisprudenza, dal 2017 in poi, definisce «assistenziale, compensativa e perequativa».
Quando il mantenimento non viene riconosciuto o cessa
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento o divorzile sorge solo a favore dell’ex coniuge al quale la fine dell’unione coniugale non è stata addebitata (per condotte che hanno fatto crollare il rapporto, come l’infedeltà o la mancata assistenza): perciò, chi ha ricevuto la pronuncia giudiziale di addebito non può essere mantenuto.
Inoltre, dopo il divorzio, per avere diritto all’assegno occorre che il beneficiario si trovi in condizioni di inferiorità economica rispetto all’ex coniuge, al punto di non potersi mantenere da solo (come abbiamo visto, dopo il divorzio non si segue più il criterio del precedente tenore di vita). Infine, l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa definitivamente se il beneficiario si risposa o avvia una nuova convivenza di fatto con un altro partner (purché sia stabile e non occasionale).
Mantenimento ex moglie che non lavora: quando spetta?
C’è, poi, un requisito essenziale per poter percepire l’assegno, oltre alla disparità di reddito: chi vanta il diritto al mantenimento deve dimostrare di essere incolpevole della propria non autosufficienza economica. La legge sul divorzio dispone che l’assegno di mantenimento spetta in favore dell’ex coniuge che «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Dunque, il richiedente mantenimento deve dimostrare la propria «meritevolezza», che si verifica quando, per motivi di età avanzata o di salute, non è più in condizioni di lavorare, o quando ha cercato, inutilmente, di trovare un’occupazione remunerata, ma non vi è riuscito. Un’altra situazione frequente è quella della donna che ha perso contatti e legami con il mondo del lavoro, specialmente se il matrimonio è stato di lunga durata e in questo periodo la moglie si è dedicata esclusivamente alle incombenze domestiche. In sintesi, per avere diritto all’assegno l’incapacità dell’ex coniuge di mantenersi autonomamente non deve dipendere da pigrizia, cattiva volontà o inerzia.
Ex moglie che non cerca lavoro: ha diritto al mantenimento?
Applicando “alla rovescia” i criteri che abbiamo esaminato, l’ex coniuge non ha diritto al mantenimento se è in giovane età, in buona salute ed in possesso di un titolo di studio o qualifiche professionali adeguate: queste caratteristiche agevolano l’inserimento lavorativo (tranne che in zone economicamente depresse o in periodi di crisi occupazionale). Così chi richiede l’assegno deve dimostrare di essersi attivato in modo concreto e volenteroso per cercare un lavoro. Se non vi è riuscito, nonostante gli sforzi, non sarà colpa sua, e avrà comunque diritto al mantenimento.
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione ritengono che il mantenimento non spetta a chi, pur potendolo fare, non si è messo alla ricerca di un impiego. L’ultima ordinanza emessa dalla Suprema Corte ha aggiunto un importante tassello: l’ex moglie che non si è attivata per cercare un lavoro ha comunque diritto al mantenimento, dopo il divorzio, se durante il matrimonio si era occupata della famiglia e della crescita dei figli, così sacrificando le sue aspirazioni professionali.
Tuttavia, nella vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour, l’assegno divorzile è stato tagliato in maniera consistente rispetto alla cifra iniziale, ed è sceso da 1.050 euro a 300 euro mensili. Questa decisione è stata presa in considerazione del fatto che la protratta «inerzia» dell’ex moglie nella ricerca di un lavoro aveva compromesso la «finalità solidaristica» tra gli ex coniugi (che nel ragionamento svolto dalla Corte è alla base del riconoscimento dell’assegno divorzile); dunque, il ricorso proposto dall’ex marito per la riduzione dell’assegno di mantenimento è stato parzialmente accolto, con un abbattimento di più di due terzi rispetto all’importo originariamente stabilito.
Consulta: illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.
È discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Questa è la conclusione della Corte costituzionale, riunitasi oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.
In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In virtù del principio di eguaglianza e dell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono avere l’opportunità di condividere la scelta sul suo cognome, elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la nuova regola prevede che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato, a meno che essi decidano, sempre di comune intesa, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In assenza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione.
Cessazione mantenimento e diritto di abitazione
Sia la raggiunta indipendenza economica che lo stato di disoccupazione incolpevole dovuto a inerzia determinano la cessazione del mantenimento e del diritto di abitazione.
È a tutti noto che, in caso di separazione di una coppia (sposata o di fatto), il giudice accorda il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale al genitore con cui il figlio va abitualmente a vivere, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro. Statisticamente, nella gran parte dei casi, è la madre a tenere sia il figlio che la casa. A questo punto, è normale chiedersi: fino a quanto dura tale diritto? Nel momento in cui il figlio perde il mantenimento la madre deve lasciare casa? La risposta è stata fornita più volte dalla giurisprudenza.
Il giudice assegna sempre la casa all’ex moglie?
Non perché una coppia si separa, la casa finisce sempre all’ex moglie. Due sono le condizioni affinché ciò avvenga. Innanzitutto, la coppia deve avere un figlio che deve essere ancora minorenne o, se maggiorenne, non ancora autosufficiente dal punto di vista economico. In secondo luogo, la madre deve essere designata dal giudice come il genitore “collocatario”, quello cioè con cui il figlio andrà a vivere e quindi a risiedere.
In pratica, la casa segue il figlio: il genitore che ottiene la collocazione del figlio può rimanere nella casa coniugale.
Se non mi sposo, la casa va alla mia ex col figlio?
Spesso, la gente crede di poter mettere al riparo la casa non sposandosi. Tuttavia, la regola dell’assegnazione della casa coniugale vale anche in presenza di una coppia di fatto.
Se la mia ex ha una casa, le spetta la mia?
Il giudice attribuisce al coniuge collocatario del figlio la casa coniugale, quella cioè dove prima la famiglia viveva. Quindi, se anche la madre è proprietaria di una propria abitazione (usata dalla famiglia come “seconda casa”), ciò non influirà sul suo diritto a continuare a restare nell’ex casa del marito o del compagno. Scopo infatti dell’assegnazione della casa coniugale è evitare che il figlio debba patire – oltre alla rottura dell’unione familiare – anche un trasferimento. Insomma, si vuol fare in modo che il bambino o il giovane continui a vivere nello stesso habitat domestico.
Come non lasciare la casa all’ex moglie?
Chi ha una casa di proprietà che non vuol lasciare all’ex, dovrà fare in modo che in essa non si svolga la vita familiare: dovrà cioè adibire a dimora abituale della famiglia un altro immobile. Perché solo su questo spetta il diritto di abitazione.
Quando la moglie deve lasciare casa al marito?
La moglie deve lasciare la casa se non ci va a vivere o se decide di trasferirsi altrove. È altresì tenuta a restituire l’immobile al marito se il figlio va a vivere da solo; il fatto che quest’ultimo frequenti l’università e faccia regolare ritorno a casa non è sufficiente per perdere il diritto di abitazione.
Se il figlio perde il mantenimento la madre deve lasciare la casa?
Poniamo ora il caso di un figlio che, nonostante l’acquisizione di un titolo di studio e un’età avanzata, non abbia ancora trovato un lavoro. Per la giurisprudenza questa è una tipica situazione in cui il ragazzo perde il diritto al mantenimento. Superati i 30 anni, al padre non è neanche richiesto dimostrare l’inerzia del figlio nella ricerca del lavoro: dopo una certa età, si presume lo stato di disoccupazione colpevole.
Detto ciò, secondo una recente pronuncia del tribunale di Foggia, una volta che il figlio perde il diritto al mantenimento – sia perché raggiunge una sua stabilità economica, sia perché al contrario, nonostante l’età, non fa nulla per cercare lavoro – la madre deve lasciare la casa all’ex marito. E difatti non c’è più alcun habitat da tutelare per i figli. Al massimo, la donna potrà chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento per se stessa anche perché dovrà cercarsi un altro alloggio.
È chiaro allora che, insieme alla madre, anche il figlio dovrà andare via perché, cessando l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori, questi perde anche il diritto di restare in casa loro.































